Proposte Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti a Cavour-Associazione Studi Storici Giovanni Giolitti
 Strappare
l'ultimo foglio dal blocchetto esaurito del calendario (quelli di una
volta, di carta sottilissima, con il numero stampato in rosso fuoco
come i bordi dei quaderni dalla copertina nera) induce a
riflettere sul tempo andato, che non vuol dire perduto, e su quello
venturo, forato da cabalistici punti interrogativi. Molti esitano a
guardare il primo gennaio 2020. Prevalgono previsioni pessimistiche, ma
sono più umorali dei bilanci truccati di tante banche da tanti anni
agonizzanti (come tutti sapevano) e di industrie condannate a morte
dall’evanescenza (altrettanto nota) dei loro prodotti. L'unica certezza
dinnanzi al cambio dei calendari è che, per i singoli come per le
Istituzioni, “fugit irreparabile tempus”. Tutto passa. Anche gli
imperi apparentemente più tetragoni hanno piedi di argilla. Senza
abbandonarsi all'amaro sarcasmo del “Dialogo di un Venditore di
Almanacchi e di un Passeggere” del realistico Giacomo Leopardi, da lì
conviene partire per una riflessione sull'anno, o meglio, sui decenni
che ci attendono. Per farlo lasciamo tra parentesi che tanti oggi
vivono di informazioni “ad horas” dalle quali dipendono fortune
gigantesche. È il caso delle borse finanziarie, sospinte da stime su
beni ancora da produrre, di risorse da estrarre, di “realtà”
baluginanti su orizzonti che danno per scontato ciò che non lo è
affatto: pace per taluni, devastazioni belliche per altri, catastrofi
naturali per i più cinici, perché sempre dal Male nasce il Bene o, più
prosaicamente, senza scomodare Zoroastro, il futuro è degli idraulici,
degli elettricisti e di chi argina la rapina dei conti in banca per
opera di abili intrusi nei sistemi di sicurezza, sempre più fallaci
(aggettivo oggettivamente inquietante).
Strappare
l'ultimo foglio dal blocchetto esaurito del calendario (quelli di una
volta, di carta sottilissima, con il numero stampato in rosso fuoco
come i bordi dei quaderni dalla copertina nera) induce a
riflettere sul tempo andato, che non vuol dire perduto, e su quello
venturo, forato da cabalistici punti interrogativi. Molti esitano a
guardare il primo gennaio 2020. Prevalgono previsioni pessimistiche, ma
sono più umorali dei bilanci truccati di tante banche da tanti anni
agonizzanti (come tutti sapevano) e di industrie condannate a morte
dall’evanescenza (altrettanto nota) dei loro prodotti. L'unica certezza
dinnanzi al cambio dei calendari è che, per i singoli come per le
Istituzioni, “fugit irreparabile tempus”. Tutto passa. Anche gli
imperi apparentemente più tetragoni hanno piedi di argilla. Senza
abbandonarsi all'amaro sarcasmo del “Dialogo di un Venditore di
Almanacchi e di un Passeggere” del realistico Giacomo Leopardi, da lì
conviene partire per una riflessione sull'anno, o meglio, sui decenni
che ci attendono. Per farlo lasciamo tra parentesi che tanti oggi
vivono di informazioni “ad horas” dalle quali dipendono fortune
gigantesche. È il caso delle borse finanziarie, sospinte da stime su
beni ancora da produrre, di risorse da estrarre, di “realtà”
baluginanti su orizzonti che danno per scontato ciò che non lo è
affatto: pace per taluni, devastazioni belliche per altri, catastrofi
naturali per i più cinici, perché sempre dal Male nasce il Bene o, più
prosaicamente, senza scomodare Zoroastro, il futuro è degli idraulici,
degli elettricisti e di chi argina la rapina dei conti in banca per
opera di abili intrusi nei sistemi di sicurezza, sempre più fallaci
(aggettivo oggettivamente inquietante). Piccoli borghi antichi.
Piccoli borghi antichi. Requiescant in pace...
Requiescant in pace... Quando lo Stato sembrò vacillare.
Quando lo Stato sembrò vacillare. Le fonti per una storia “a parti intere”
Le fonti per una storia “a parti intere” 1919: abolizione dell' “autorizzazione maritale”
1919: abolizione dell' “autorizzazione maritale” L'unico “successo” del socialista Sánchez: la rimozione di Franco
L'unico “successo” del socialista Sánchez: la rimozione di Franco  Alla ricerca dell'eternità
Alla ricerca dell'eternità  I Neet: la putrefazione dell'unità nazionale
I Neet: la putrefazione dell'unità nazionale Lo
scarno “Diario della Casa Militare del Re”, ricostruito per il
1922-1924 su agende del Primo aiutante di campo e carte
dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Quirinale, e l'“Itinerario
generale” dal 1° giugno 1896 al 24 ottobre 1946, manoscritto ad
Alessandria d'Egitto da Vittorio Emanuele III, dicono l'essenziale
delle “opere e giorni” del sovrano che per mezzo secolo resse le sorti
dell'Italia. Tra i pochi fatti di rilievo del settembre-ottobre 1922
spiccano le sue visite agli studi del pittore Giuseppe Augusto Levis (a
Racconigi) e dello scultore Leonardo Bistolfi (a Torino), il viaggio in
Belgio (10-14 ottobre) e il rientro in treno da San Rossore (Pisa) a
Roma, la sera del 27 ottobre, ove il presidente del Consiglio Luigi
Facta gli presentò le dimissioni del governo. Dalle 10.30 dell'indomani
il Re ricevette al Quirinale i presidenti delle Camere (Tittoni e De
Nicola), Cocco Ortu, Orlando, Federzoni, Salandra, De Nava e De Vecchi.
Non vi sono appunti per i tre giorni seguenti, nei quali, fallita
l'ipotesi di un governo Salandra e assenti da Roma Giolitti e Meda,
rappresentanti delle maggiori forze costituzionali, sentiti in via
breve direttamente e indirettamente i portavoce del Paese, il 29 il Re
anticipò l'incarico a Benito Mussolini, che giunse a Roma la mattina
del 30, presentò la lista dei ministri e il 31 si insediò a capo di un
governo di unione costituzionale comprendente fascisti, nazionalisti,
popolari, democratici sociali, giolittiani, Gentile all'Istruzione, il
generale Diaz alla Guerra e l'ammiraglio Thaon di Revel alla Marina. Lo
stesso 31, dopo giorni di attesa sotto la pioggerella autunnale con
poche munizioni da fuoco e da bocca, gli “squadristi” sfilarono per
Roma preceduti dalla banda musicale capitolina e ne partirono con treni
sveltamente allestiti. L'indomani Roma era tranquilla, come d'uso. Il 4
il Re si recò all'Altare della Patria e il 5 partì per San Rossore.
L'Italia aveva un governo, approvato il 17 novembre alla Camera con 306
voti contro 116 e il 27 al Senato, ove ebbe 19 voti contrari su 398
membri. All'opposto di quanto a lungo ripetuto quella coalizione non fu
affatto “subito regime”. La Camera era quella eletta nel maggio 1921
con la regìa di Giolitti. Il Senato contava appena due iscritti al
Partito fascista.
Lo
scarno “Diario della Casa Militare del Re”, ricostruito per il
1922-1924 su agende del Primo aiutante di campo e carte
dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Quirinale, e l'“Itinerario
generale” dal 1° giugno 1896 al 24 ottobre 1946, manoscritto ad
Alessandria d'Egitto da Vittorio Emanuele III, dicono l'essenziale
delle “opere e giorni” del sovrano che per mezzo secolo resse le sorti
dell'Italia. Tra i pochi fatti di rilievo del settembre-ottobre 1922
spiccano le sue visite agli studi del pittore Giuseppe Augusto Levis (a
Racconigi) e dello scultore Leonardo Bistolfi (a Torino), il viaggio in
Belgio (10-14 ottobre) e il rientro in treno da San Rossore (Pisa) a
Roma, la sera del 27 ottobre, ove il presidente del Consiglio Luigi
Facta gli presentò le dimissioni del governo. Dalle 10.30 dell'indomani
il Re ricevette al Quirinale i presidenti delle Camere (Tittoni e De
Nicola), Cocco Ortu, Orlando, Federzoni, Salandra, De Nava e De Vecchi.
Non vi sono appunti per i tre giorni seguenti, nei quali, fallita
l'ipotesi di un governo Salandra e assenti da Roma Giolitti e Meda,
rappresentanti delle maggiori forze costituzionali, sentiti in via
breve direttamente e indirettamente i portavoce del Paese, il 29 il Re
anticipò l'incarico a Benito Mussolini, che giunse a Roma la mattina
del 30, presentò la lista dei ministri e il 31 si insediò a capo di un
governo di unione costituzionale comprendente fascisti, nazionalisti,
popolari, democratici sociali, giolittiani, Gentile all'Istruzione, il
generale Diaz alla Guerra e l'ammiraglio Thaon di Revel alla Marina. Lo
stesso 31, dopo giorni di attesa sotto la pioggerella autunnale con
poche munizioni da fuoco e da bocca, gli “squadristi” sfilarono per
Roma preceduti dalla banda musicale capitolina e ne partirono con treni
sveltamente allestiti. L'indomani Roma era tranquilla, come d'uso. Il 4
il Re si recò all'Altare della Patria e il 5 partì per San Rossore.
L'Italia aveva un governo, approvato il 17 novembre alla Camera con 306
voti contro 116 e il 27 al Senato, ove ebbe 19 voti contrari su 398
membri. All'opposto di quanto a lungo ripetuto quella coalizione non fu
affatto “subito regime”. La Camera era quella eletta nel maggio 1921
con la regìa di Giolitti. Il Senato contava appena due iscritti al
Partito fascista. 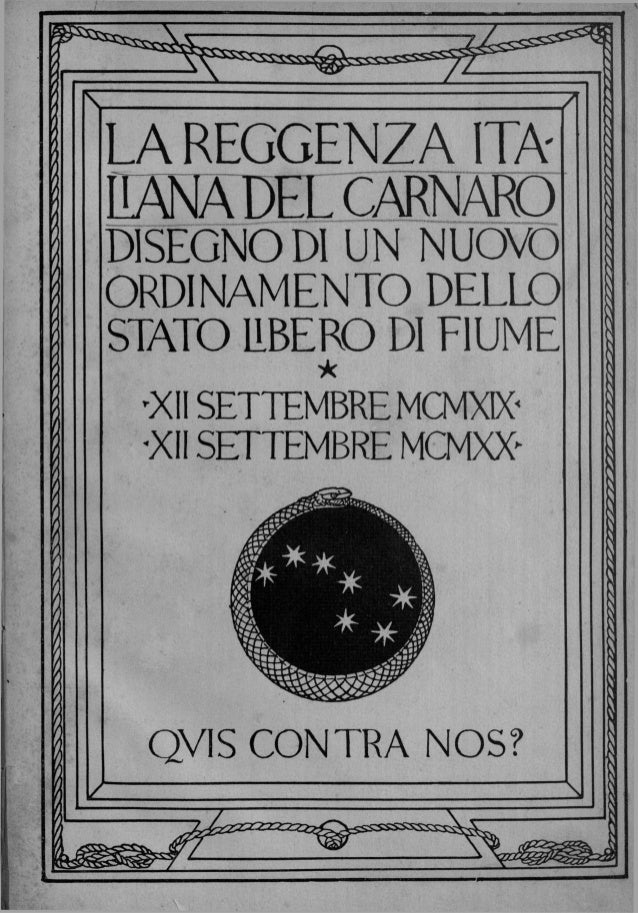 Il Vento soffia dove vuole
Il Vento soffia dove vuole  Quando il braidese Giovanni Piumati insegnava italiano a Guglielmo II
Quando il braidese Giovanni Piumati insegnava italiano a Guglielmo II  Legionari in cerca di un lavoro qualunque
Legionari in cerca di un lavoro qualunque Italia del dopoguerra: solida nella realtà, debole nell'immagine
Italia del dopoguerra: solida nella realtà, debole nell'immagine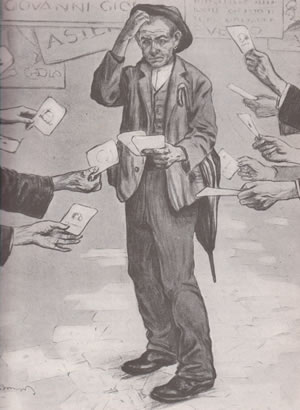 La funzione storica dei collegi uninominali (1848-1919)
La funzione storica dei collegi uninominali (1848-1919) Le tre Italie e il mito del “sorpasso”
Le tre Italie e il mito del “sorpasso” 13 aprile 1850: quando Cavour fece fischiare una palla...
13 aprile 1850: quando Cavour fece fischiare una palla... I “casi” della Storia
I “casi” della Storia Il “leghista” Guicciardini a lezione da Ferdinando il Cattolico
Il “leghista” Guicciardini a lezione da Ferdinando il Cattolico Guardie e ladri: il gioco d'infanzia tagliato sull'Italia
Guardie e ladri: il gioco d'infanzia tagliato sull'Italia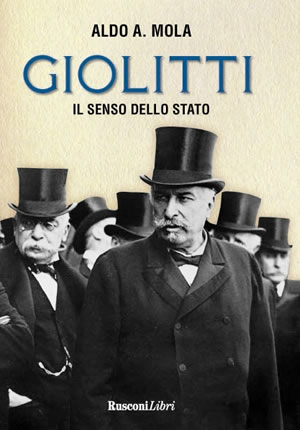 Vi
sono parecchie ragioni per ricordare Giovanni Giolitti (Mondovì, 127
ottobre 1842.- Cavour, 17 luglio 1928), massimo statista italiano dalla
proclamazione del Regno d'Italia a oggi. Ne ricordiamo almeno quattro.
(*)
Vi
sono parecchie ragioni per ricordare Giovanni Giolitti (Mondovì, 127
ottobre 1842.- Cavour, 17 luglio 1928), massimo statista italiano dalla
proclamazione del Regno d'Italia a oggi. Ne ricordiamo almeno quattro.
(*) Quando Romano Prodi profetizzò la riscoperta della via Francigena
Quando Romano Prodi profetizzò la riscoperta della via Francigena E
così, alla faccia di Karl Marx, grazie a una leggina senza oneri per lo
Stato, in Italia trionfa il Partito dei Capitalisti. Non è quello di
George Soros, l'ebreo ungherese naturalizzato statunitense che manipola
immense fortune e soggioga governi come fosse Spectre. Non è neppure la
allegra brigata che inventa la nuova libra, spaccia bitcoin, sogna di
stampare nottetempo carta moneta più o meno fasulla e magari i
“mini-bot”, sdrucita sottoveste degli antichi “pagherò”. Questi sono
tardivi imitatori del frammassone settecentesco Giuseppe Balsamo. Noto
come Alessandro conte di Cagliostro, dai muri umidi il “mago” grattava
il bicarbonato per propiziare la digestione dei suoi “clienti” e
incitava i gonzi a soffiare in canne attorno al pentolone nel quale il
piombo sarebbe divenuto oro. Balsamo finì nel caveau di San Leo su
ordine di papa Pio VI e vi morì dopo anni di bastonate e di urla
strazianti.
E
così, alla faccia di Karl Marx, grazie a una leggina senza oneri per lo
Stato, in Italia trionfa il Partito dei Capitalisti. Non è quello di
George Soros, l'ebreo ungherese naturalizzato statunitense che manipola
immense fortune e soggioga governi come fosse Spectre. Non è neppure la
allegra brigata che inventa la nuova libra, spaccia bitcoin, sogna di
stampare nottetempo carta moneta più o meno fasulla e magari i
“mini-bot”, sdrucita sottoveste degli antichi “pagherò”. Questi sono
tardivi imitatori del frammassone settecentesco Giuseppe Balsamo. Noto
come Alessandro conte di Cagliostro, dai muri umidi il “mago” grattava
il bicarbonato per propiziare la digestione dei suoi “clienti” e
incitava i gonzi a soffiare in canne attorno al pentolone nel quale il
piombo sarebbe divenuto oro. Balsamo finì nel caveau di San Leo su
ordine di papa Pio VI e vi morì dopo anni di bastonate e di urla
strazianti.  Benedetto Croce: il rifiuto dello “Stato etico”
Benedetto Croce: il rifiuto dello “Stato etico”  Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando dichiara,
epigrammatico e allusivo, e soprattutto quando osserva, distaccato e
silente, sempre più evoca Carlo Alberto di Savoia, il sovrano che il 4
marzo 1848 promulgò lo Statuto del Regno di Sardegna. Identiche le loro
virtù teologali, Fede, Speranza e Carità. Uguale la compostezza. E quel
velo di arcana mestizia che trapela anche quando il volto sorride a
labbra strette. Entrambi rappresentano il passaggio da uno ad altro
Ordinamento dello Stato. Quello varato da Carlo Alberto durò un secolo.
Il Presidente Mattarella regge il timone della Nave Italia, repubblica
da appena 71 anni. È il nocchiero di cui il Paese ha bisogno, mentre i
venti di tempesta rafforzano. Oggi non sono in discussione un governo,
una maggioranza, poltrone varie. Sotto l'infuriare della tempesta
stridono le funi e gemono i legni dello Stato. Reggeranno? Gli
ufficiali di bordo conoscono la rotta? Ascoltano e capiscono gli ordini
del Condottiero? Di sicuro tanta parte della ciurma alle urne fa
l'“ammuina”, correndo tumultuosa da un capitano a un capo fazione,
tutti “nomi” estranei alla nobile tradizione durata dalle “Vite
Parallele” di Plutarco ai “Rerum Gestarum” di Ammiano Marcellino.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando dichiara,
epigrammatico e allusivo, e soprattutto quando osserva, distaccato e
silente, sempre più evoca Carlo Alberto di Savoia, il sovrano che il 4
marzo 1848 promulgò lo Statuto del Regno di Sardegna. Identiche le loro
virtù teologali, Fede, Speranza e Carità. Uguale la compostezza. E quel
velo di arcana mestizia che trapela anche quando il volto sorride a
labbra strette. Entrambi rappresentano il passaggio da uno ad altro
Ordinamento dello Stato. Quello varato da Carlo Alberto durò un secolo.
Il Presidente Mattarella regge il timone della Nave Italia, repubblica
da appena 71 anni. È il nocchiero di cui il Paese ha bisogno, mentre i
venti di tempesta rafforzano. Oggi non sono in discussione un governo,
una maggioranza, poltrone varie. Sotto l'infuriare della tempesta
stridono le funi e gemono i legni dello Stato. Reggeranno? Gli
ufficiali di bordo conoscono la rotta? Ascoltano e capiscono gli ordini
del Condottiero? Di sicuro tanta parte della ciurma alle urne fa
l'“ammuina”, correndo tumultuosa da un capitano a un capo fazione,
tutti “nomi” estranei alla nobile tradizione durata dalle “Vite
Parallele” di Plutarco ai “Rerum Gestarum” di Ammiano Marcellino.
 Ferruccio Fazio neo-sindaco di Garessio
Ferruccio Fazio neo-sindaco di Garessio  Giovane vecchia Europa
Giovane vecchia Europa  Una crisi senza soluzioni?
Una crisi senza soluzioni? Il
mondo contemporaneo invita a riflettere su quello di mezzo millennio
addietro e a interrogarsi sulle prospettive venture. L'attuale è
imperniato su una potenza neo-europea, gli Stati Uniti d'America, in
contrapposizione a una asiatica, la Cina. Gli USA hanno nell'Unione
Europea un alleato politicamente sfrangiato, non sempre affidabile, e
militarmente piatto. Alcuni suoi membri trattano direttamente coi
cinesi accordi economici, quasi che questi non ne implichino altri,
politici e militari, connessi alle diverse e spesso distanti concezioni
dell'uomo e dei suoi diritti. Gli USA si confrontano con un altro
avversario, la Federazione Russa, che, di radici e cultura
indiscutibilmente europea, si pone militarmente come potenza “terza”,
anche se la sua effettiva forza economica e bellica in prospettiva di
lungo periodo appare declinante.
Il
mondo contemporaneo invita a riflettere su quello di mezzo millennio
addietro e a interrogarsi sulle prospettive venture. L'attuale è
imperniato su una potenza neo-europea, gli Stati Uniti d'America, in
contrapposizione a una asiatica, la Cina. Gli USA hanno nell'Unione
Europea un alleato politicamente sfrangiato, non sempre affidabile, e
militarmente piatto. Alcuni suoi membri trattano direttamente coi
cinesi accordi economici, quasi che questi non ne implichino altri,
politici e militari, connessi alle diverse e spesso distanti concezioni
dell'uomo e dei suoi diritti. Gli USA si confrontano con un altro
avversario, la Federazione Russa, che, di radici e cultura
indiscutibilmente europea, si pone militarmente come potenza “terza”,
anche se la sua effettiva forza economica e bellica in prospettiva di
lungo periodo appare declinante.  Stati e lunga durata degli interessi dei cittadini
Stati e lunga durata degli interessi dei cittadini Con la
visita all'Altare della Patria e a Vittorio Veneto, il Milite Ignoto e
la città sacra alla Vittoria del IV novembre 1918, ancora una volta il
Capo dello Stato Sergio Mattarella ha indicato, col linguaggio dei
simboli e dei luoghi memoriali, la parabola della vera storia d'Italia
nel giorno convenzionale della liberazione dalla guerra e dell'inizio
della Ricostruzione. Questa voleva, doveva e dovrebbe essere l'unità
Stato-Nazione e della fratellanza tra i popoli nella giustizia
internazionale: “pax in iure gentium”, la divisa della “Corda Fratres”.
A un mese dall’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo il
mònito del Presidente giunge puntuale. Ricorda l'abissale differenza
tra l'Europa attuale, da quasi 75 anni in pace (sia pure “armata”)
dall'Atlantico a Vladivostok, e quella del 1919-1920, gli anni delle
paci sbagliate, o quella del 1945-1946, che videro l'inizio della
guerra fredda, greve e opprimente negli Stati sotto giogo dell'URSS, ma
sempre meglio che sotto le bombe atomiche.
Con la
visita all'Altare della Patria e a Vittorio Veneto, il Milite Ignoto e
la città sacra alla Vittoria del IV novembre 1918, ancora una volta il
Capo dello Stato Sergio Mattarella ha indicato, col linguaggio dei
simboli e dei luoghi memoriali, la parabola della vera storia d'Italia
nel giorno convenzionale della liberazione dalla guerra e dell'inizio
della Ricostruzione. Questa voleva, doveva e dovrebbe essere l'unità
Stato-Nazione e della fratellanza tra i popoli nella giustizia
internazionale: “pax in iure gentium”, la divisa della “Corda Fratres”.
A un mese dall’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo il
mònito del Presidente giunge puntuale. Ricorda l'abissale differenza
tra l'Europa attuale, da quasi 75 anni in pace (sia pure “armata”)
dall'Atlantico a Vladivostok, e quella del 1919-1920, gli anni delle
paci sbagliate, o quella del 1945-1946, che videro l'inizio della
guerra fredda, greve e opprimente negli Stati sotto giogo dell'URSS, ma
sempre meglio che sotto le bombe atomiche. 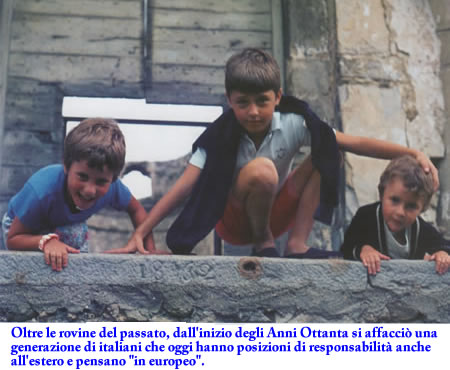 Una guerra mondiale fa
Una guerra mondiale fa Meglio tardi che mai: il Genocidio degli Armeni denunciato dalla Camera
Meglio tardi che mai: il Genocidio degli Armeni denunciato dalla Camera Nel 70° della NATO il presidente degli USA, suo “socio di maggioranza”,
richiama ruvidamente l'Italia a investire il dovuto per la difesa, come
richiesto dal Trattato. Incontra il consenso del Presidente Mattarella,
capo delle Forze Armate, come lo era il Re, che comandava le forze di
terra e di mare. I “militari” tacciono. I “politici” si voltano da
un'altra parte. Nulla di nuovo sotto il sole italiano. Dall'Unità i
governi hanno sempre speso il meno possibile per lo “strumento
militare”, salvo imporgli imprese al limite dell'impossibile. Crispi
pretese troppo nella prima rovinosa guerra d'Africa (1893-1896),
Giolitti sottovalutò la durata dell'impresa di Libia (1911-1912).
Peggiori furono Salandra e Sonnino che nell'aprile-maggio 1915
gettarono l'Italia nella grande fornace della guerra europea sbagliando
tutte le previsioni. Anch'essi chiesero al Capo di Stato Maggiore,
Luigi Cadorna, di farsi carico di condurre una guerra offensiva, senza
mettergli a disposizione lo stretto necessario: armi, magazzini,
crediti... e, ciò che più conta, una condotta lineare della politica
estera, indispensabile per un Paese che nel conflitto entrò dopo essere
stato per una settimana alleato di tutti, salvo poi denunciare
un'alleanza che durava dal 1882.
Nel 70° della NATO il presidente degli USA, suo “socio di maggioranza”,
richiama ruvidamente l'Italia a investire il dovuto per la difesa, come
richiesto dal Trattato. Incontra il consenso del Presidente Mattarella,
capo delle Forze Armate, come lo era il Re, che comandava le forze di
terra e di mare. I “militari” tacciono. I “politici” si voltano da
un'altra parte. Nulla di nuovo sotto il sole italiano. Dall'Unità i
governi hanno sempre speso il meno possibile per lo “strumento
militare”, salvo imporgli imprese al limite dell'impossibile. Crispi
pretese troppo nella prima rovinosa guerra d'Africa (1893-1896),
Giolitti sottovalutò la durata dell'impresa di Libia (1911-1912).
Peggiori furono Salandra e Sonnino che nell'aprile-maggio 1915
gettarono l'Italia nella grande fornace della guerra europea sbagliando
tutte le previsioni. Anch'essi chiesero al Capo di Stato Maggiore,
Luigi Cadorna, di farsi carico di condurre una guerra offensiva, senza
mettergli a disposizione lo stretto necessario: armi, magazzini,
crediti... e, ciò che più conta, una condotta lineare della politica
estera, indispensabile per un Paese che nel conflitto entrò dopo essere
stato per una settimana alleato di tutti, salvo poi denunciare
un'alleanza che durava dal 1882.  Fu
il torinese Giacomo Treves, ebreo e massone (1882-1947), l'artefice
segreto della “marcia di Ronchi” capitanata da Gabriele d'Annunzio
nella notte del 12 settembre 1919 per affermare l'italianità di Fiume.
Dall'origine l'“impresa” è al centro di giudizi controversi. “Festa
della rivoluzione” secondo Claudia Salaris; “una delle più buffonesche
italianate della nostra Storia” per Indro Montanelli, che però
(confessò) se avesse avuto vent'anni forse vi si sarebbe divertito.
Già, perché Fiume fu… un fiume in piena, Verbo che si fa Carne, con
volontari, legionari, ammiratori, spregiatori, morti e feriti. E
soprattutto tanti delusi. Com’era stata la Repubblica romana del 1849,
morta proprio quando la sua Assemblea ne approvò la costituzione. A
Fiume il Verbo si fece anche carnascialesco. “Severità e goliardia,
gioco e guerra, amore e violenza”, la “città martire” divenne un'icona
in un Paese dalla memoria labile. Lo scrive Giordano Bruno Guerri in
“Disobbedisco. Fiume 1919-1920” (Mondadori) sulla scorta dell'imponente
Archivio della Fondazione del Vittoriale degli Italiani da lui diretto
(Gardone Riviera, www.vittoriale.it).
Fu
il torinese Giacomo Treves, ebreo e massone (1882-1947), l'artefice
segreto della “marcia di Ronchi” capitanata da Gabriele d'Annunzio
nella notte del 12 settembre 1919 per affermare l'italianità di Fiume.
Dall'origine l'“impresa” è al centro di giudizi controversi. “Festa
della rivoluzione” secondo Claudia Salaris; “una delle più buffonesche
italianate della nostra Storia” per Indro Montanelli, che però
(confessò) se avesse avuto vent'anni forse vi si sarebbe divertito.
Già, perché Fiume fu… un fiume in piena, Verbo che si fa Carne, con
volontari, legionari, ammiratori, spregiatori, morti e feriti. E
soprattutto tanti delusi. Com’era stata la Repubblica romana del 1849,
morta proprio quando la sua Assemblea ne approvò la costituzione. A
Fiume il Verbo si fece anche carnascialesco. “Severità e goliardia,
gioco e guerra, amore e violenza”, la “città martire” divenne un'icona
in un Paese dalla memoria labile. Lo scrive Giordano Bruno Guerri in
“Disobbedisco. Fiume 1919-1920” (Mondadori) sulla scorta dell'imponente
Archivio della Fondazione del Vittoriale degli Italiani da lui diretto
(Gardone Riviera, www.vittoriale.it). Il 1928 in pochi
mesi portò via Armando Diaz (classe 1861), Giovanni Giolitti (1842) e
Luigi Cadorna (1850), tre massimi protagonisti della storia d'Italia:
lo Statista e i due Comandanti Supremi dell'esercito nella Grande
guerra. Diaz non lasciò memorie. Le sue carte sono state studiate e
valorizzate dal generale Luigi Gratton (2001), fiero di essere stato
alfiere del Tricolore al rientro dell'Italia a Trieste nel 1954.
Giolitti pubblicò le Memorie della sua vita nel suo 80° compleanno, il
27 ottobre 1922. Nei sei anni seguenti non aggiunse nulla, né rilasciò
interviste. Ma il 16 marzo 1924, vigilia delle elezioni vinte dal
“listone nazionale” filofascista che candidò Enrico De Nicola a Napoli
e Vittorio Emanuele Orlando in Sicilia, Giolitti deplorò la deriva
precipitosa dalla democrazia liberale di Azeglio, Cavour e Sella al
“partito unico”, sempre con l'avallo della Camera dei deputati, pronuba
dinnanzi al “duce”, che ripetutamente la umiliò con parole sferzanti.
Dal canto suo Cadorna non tenne un “Diario” né pubblicò
“memorie”. Però cent'anni orsono fece di più e di meglio. Nel
1919, vergò la sua opera fondamentale: “La guerra alla fronte italiana
fino all'arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915-9
novembre 1917)”. Non generici “ricordi” personali ma Storia, densa di
documenti e di atti ufficiali. L'opera è la “biografia” dell'Italia
dalla Conflagrazione europea (luglio1914) alla sostituzione di
Cadorna con Armando Diaz a capo dell'Esercito italiano (9 novembre
1917).
Il 1928 in pochi
mesi portò via Armando Diaz (classe 1861), Giovanni Giolitti (1842) e
Luigi Cadorna (1850), tre massimi protagonisti della storia d'Italia:
lo Statista e i due Comandanti Supremi dell'esercito nella Grande
guerra. Diaz non lasciò memorie. Le sue carte sono state studiate e
valorizzate dal generale Luigi Gratton (2001), fiero di essere stato
alfiere del Tricolore al rientro dell'Italia a Trieste nel 1954.
Giolitti pubblicò le Memorie della sua vita nel suo 80° compleanno, il
27 ottobre 1922. Nei sei anni seguenti non aggiunse nulla, né rilasciò
interviste. Ma il 16 marzo 1924, vigilia delle elezioni vinte dal
“listone nazionale” filofascista che candidò Enrico De Nicola a Napoli
e Vittorio Emanuele Orlando in Sicilia, Giolitti deplorò la deriva
precipitosa dalla democrazia liberale di Azeglio, Cavour e Sella al
“partito unico”, sempre con l'avallo della Camera dei deputati, pronuba
dinnanzi al “duce”, che ripetutamente la umiliò con parole sferzanti.
Dal canto suo Cadorna non tenne un “Diario” né pubblicò
“memorie”. Però cent'anni orsono fece di più e di meglio. Nel
1919, vergò la sua opera fondamentale: “La guerra alla fronte italiana
fino all'arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915-9
novembre 1917)”. Non generici “ricordi” personali ma Storia, densa di
documenti e di atti ufficiali. L'opera è la “biografia” dell'Italia
dalla Conflagrazione europea (luglio1914) alla sostituzione di
Cadorna con Armando Diaz a capo dell'Esercito italiano (9 novembre
1917).  Comunione e confessione prima del Gran Consiglio
Comunione e confessione prima del Gran Consiglio Il neo-meridionalismo siculocentrico di Andrea Camilleri...
Il neo-meridionalismo siculocentrico di Andrea Camilleri... Lo Spirito e la Terra tra due mari
Lo Spirito e la Terra tra due mari Geografia e storia della sofferenza umana
Geografia e storia della sofferenza umana Povera e nuda vai, Filosofia: l'Esecutivo allo sbando.
Povera e nuda vai, Filosofia: l'Esecutivo allo sbando.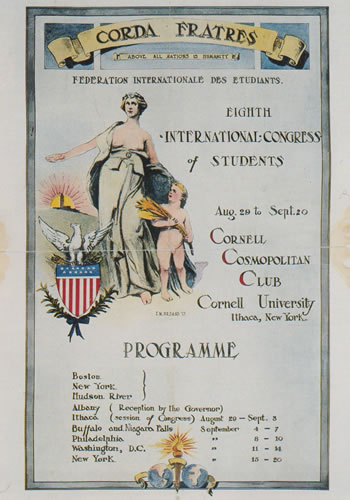 Dalle incomprensioni...
Dalle incomprensioni... Anche se “prigioniero” il papa era sovrano...
Anche se “prigioniero” il papa era sovrano... Le “ingerenze straniere” di cent'anni fa. Il presidente USA Wilson
Le “ingerenze straniere” di cent'anni fa. Il presidente USA Wilson  Un “Contratto di governo” senza capo né coda
Un “Contratto di governo” senza capo né coda 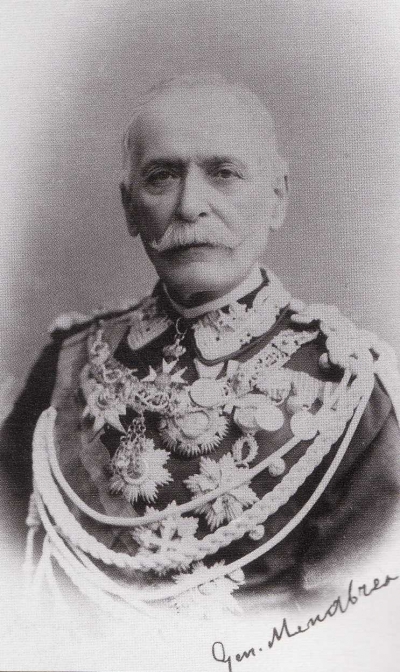 Intuire i secoli dei secoli
Intuire i secoli dei secoli La sacralità della Corona Ferrea
La sacralità della Corona Ferrea I Diritti umani: settantenni di belle speranze
I Diritti umani: settantenni di belle speranze L'attuale confusione dei poteri
L'attuale confusione dei poteri  Solo nei regimi totalitari e fatalmente destinati alla rovina
propria e dei “sudditi” i dittatori cambiano a capriccio i dirigenti
dei comparti apicali di pubblico rilievo. La competenza, infatti, non è
figlia di improvvisazione, di “convinzioni politiche”, ma di studio e
di esperienza. Il “governo”, quali ne siano il “colore” e le ambizioni,
non può prescindere dallo Stato: una piramide gerarchica costruita non
a difesa di privilegi ma a tutela dei diritti e degli interessi
generali permanenti dei cittadini. Si può certo obiettare che da tempo
al vertice delle responsabilità si trovano talora persone inadeguate.
Se però se ne cerca la cagione, si scopre che gli inetti si trovano
dove sono “per nomina ad nutum principis” anziché per concorso
pubblico non manipolato, proprio perché sono frutto della degenerazione
che lentamente ha corroso lo Stato liberale, fondato sulla uguaglianza
dei diritti dinnanzi alle leggi e sulla certificazione delle carriere.
Solo nei regimi totalitari e fatalmente destinati alla rovina
propria e dei “sudditi” i dittatori cambiano a capriccio i dirigenti
dei comparti apicali di pubblico rilievo. La competenza, infatti, non è
figlia di improvvisazione, di “convinzioni politiche”, ma di studio e
di esperienza. Il “governo”, quali ne siano il “colore” e le ambizioni,
non può prescindere dallo Stato: una piramide gerarchica costruita non
a difesa di privilegi ma a tutela dei diritti e degli interessi
generali permanenti dei cittadini. Si può certo obiettare che da tempo
al vertice delle responsabilità si trovano talora persone inadeguate.
Se però se ne cerca la cagione, si scopre che gli inetti si trovano
dove sono “per nomina ad nutum principis” anziché per concorso
pubblico non manipolato, proprio perché sono frutto della degenerazione
che lentamente ha corroso lo Stato liberale, fondato sulla uguaglianza
dei diritti dinnanzi alle leggi e sulla certificazione delle carriere. V'è motivo di riflettere sulla Vittoria del IV novembre 1918. Ancora
una volta il “governo” vaga lontano dalla realtà dei patti vigenti,
dall'Alleanza difensiva di cui l'Italia è componente e dai vincoli
militari e finanziari che essi comportano. Non ha una linea chiara di
politica estera. Farfuglia con inflessioni regionali, senza una chiara
lingua dello Stato d'Italia. Gioca a rimpiattino. Ma la Storia, come la
Geografia, non fa sconti. Non ne ha mai fatti.
V'è motivo di riflettere sulla Vittoria del IV novembre 1918. Ancora
una volta il “governo” vaga lontano dalla realtà dei patti vigenti,
dall'Alleanza difensiva di cui l'Italia è componente e dai vincoli
militari e finanziari che essi comportano. Non ha una linea chiara di
politica estera. Farfuglia con inflessioni regionali, senza una chiara
lingua dello Stato d'Italia. Gioca a rimpiattino. Ma la Storia, come la
Geografia, non fa sconti. Non ne ha mai fatti.  Giovanni Gronchi nel governo Mussolini (1922-1923)
Giovanni Gronchi nel governo Mussolini (1922-1923) Gli italiani non meritano un governo indeciso a tutto
tranne che nel cacciare i migliori uomini di Stato, anche in posizioni
strategiche (ora è la volta dei vertici del Tesoro, se non addirittura
del ministro) e sostituirli con segugi meno competenti. Il regime
incipiente, capeggiato dal “Vis-Conte dimezzato” non ha nulla a che
vedere con tutti quelli del passato, compreso quello di Mussolini. Il
paragone che all'estero fanno tra alcuni tonitruanti ministri attuali e
quelli di un secolo fa si fonda sulla scarsa informazione del nostro
passato. Però, se Oltralpe la vera storia d'Italia è poco nota o viene
addirittura falsata non dipende da chissà quale complotto: è solo la
conseguenza del pluridecennale sottoutilizzo di istituti culturali
dello Stato e del piacere “sadomaso” di elevare a oracoli chi
all'estero ha motivo di narrare l'Italia come sequenza di dittature e
di maschere carnevalesche: il Paese dei Cola di Rienzo, dei Masaniello,
di comici che s'impancano a profeti, circondati da nullità spacciate
come “capi politici”. Basti ricordare quanto incenso la “storiografia”
italiota (soprattutto “di sinistra”) ha bruciato in onore di Denis Mack
Smith. I “sorrisi beffardi ” riservatici dall'estero (tutti ricordano
quelli di Merkel e Sarkozy...) nascono dalla debolezza della nostra
“proposta culturale”, che ancor oggi, nel Centenario della Vittoria,
non dice una parola chiara sull'Italia (unitaria? federalista? sabauda?
borbonica? o addirittura asburgica e papista), confermandosi “a
noleggio” e sempre più scarna e irrilevante. Basti, a conferma, il
silenzio che quest'anno ha avvolto il Venti Settembre e fa
temere il peggio per il 150° anniversario di Porta Pia.
Gli italiani non meritano un governo indeciso a tutto
tranne che nel cacciare i migliori uomini di Stato, anche in posizioni
strategiche (ora è la volta dei vertici del Tesoro, se non addirittura
del ministro) e sostituirli con segugi meno competenti. Il regime
incipiente, capeggiato dal “Vis-Conte dimezzato” non ha nulla a che
vedere con tutti quelli del passato, compreso quello di Mussolini. Il
paragone che all'estero fanno tra alcuni tonitruanti ministri attuali e
quelli di un secolo fa si fonda sulla scarsa informazione del nostro
passato. Però, se Oltralpe la vera storia d'Italia è poco nota o viene
addirittura falsata non dipende da chissà quale complotto: è solo la
conseguenza del pluridecennale sottoutilizzo di istituti culturali
dello Stato e del piacere “sadomaso” di elevare a oracoli chi
all'estero ha motivo di narrare l'Italia come sequenza di dittature e
di maschere carnevalesche: il Paese dei Cola di Rienzo, dei Masaniello,
di comici che s'impancano a profeti, circondati da nullità spacciate
come “capi politici”. Basti ricordare quanto incenso la “storiografia”
italiota (soprattutto “di sinistra”) ha bruciato in onore di Denis Mack
Smith. I “sorrisi beffardi ” riservatici dall'estero (tutti ricordano
quelli di Merkel e Sarkozy...) nascono dalla debolezza della nostra
“proposta culturale”, che ancor oggi, nel Centenario della Vittoria,
non dice una parola chiara sull'Italia (unitaria? federalista? sabauda?
borbonica? o addirittura asburgica e papista), confermandosi “a
noleggio” e sempre più scarna e irrilevante. Basti, a conferma, il
silenzio che quest'anno ha avvolto il Venti Settembre e fa
temere il peggio per il 150° anniversario di Porta Pia.  Vivano la lince e un “carbonaro” del 1821!
Vivano la lince e un “carbonaro” del 1821! Una crisi che arriva da lontano
Una crisi che arriva da lontano Lo Stato d'Italia regge sull'equilibrio dei poteri istituzionali
apicali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. La
magistratura non è un potere ma un ordine. La Corte costituzionale è
organo di garanzia. I pilastri, dunque, sono tre. Se uno si inclina,
deforma il triangolo costituzionale da equilatero in scaleno, con tutte
le possibili conseguenze, sino al possibile crollo del regime. È quanto
sta accadendo. Il silenzio del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, non potrà durare a lungo dinnanzi al rischio che il governo
trascini lo Stato stesso nel proprio prevedibile collasso. In gioco non
c'è il cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento”, con tutte
le sue contraddizioni, reticenze, promesse e violazioni patenti della
Costituzione. Codesto Contratto, va ricordato, non ha alcuna valenza
pubblica, erga omnes: è l'intesa tra due forze politico-parlamentari,
geneticamente diverse e incompatibili e quindi da un'unione
infeconda, destinata a durare come tante altre in passato.
Lo Stato d'Italia regge sull'equilibrio dei poteri istituzionali
apicali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. La
magistratura non è un potere ma un ordine. La Corte costituzionale è
organo di garanzia. I pilastri, dunque, sono tre. Se uno si inclina,
deforma il triangolo costituzionale da equilatero in scaleno, con tutte
le possibili conseguenze, sino al possibile crollo del regime. È quanto
sta accadendo. Il silenzio del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, non potrà durare a lungo dinnanzi al rischio che il governo
trascini lo Stato stesso nel proprio prevedibile collasso. In gioco non
c'è il cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento”, con tutte
le sue contraddizioni, reticenze, promesse e violazioni patenti della
Costituzione. Codesto Contratto, va ricordato, non ha alcuna valenza
pubblica, erga omnes: è l'intesa tra due forze politico-parlamentari,
geneticamente diverse e incompatibili e quindi da un'unione
infeconda, destinata a durare come tante altre in passato.  Il 28 agosto 1944 la principessa Mafalda di Savoia (“Muti”,
in famiglia), consorte di Filippo Landgravio d'Assia, morì dopo una
tardiva amputazione del braccio sinistro, ustionato sino all'osso,
per fermare la cancrena generata dagli spezzoni di bombe
anglo-americane che l'avevano ferita. L'intervento ebbe luogo
nell'ambulatorio improvvisato nel postribolo del campo di
concentramento di Buchenwald. Il 24 precedente migliaia di fortezze
volanti partite da basi remote bombardarono a tappeto le Officine
Gustloff e i dintorni. Churchill, in visita a Napoli, voleva dare una
lezione alla Germania, già piegata dalla sconfitta inflittale dai
sovietici a Kursk. Nessuno immaginava che al bordo del campo vivesse la
figlia di Vittorio Emanuele III, catturata a Roma il 22 settembre 1943
per ordine di Hitler e lì detenuta dal 8 ottobre. “Povera foglia
frale...” la Principessa lasciò la vita terrena.
Il 28 agosto 1944 la principessa Mafalda di Savoia (“Muti”,
in famiglia), consorte di Filippo Landgravio d'Assia, morì dopo una
tardiva amputazione del braccio sinistro, ustionato sino all'osso,
per fermare la cancrena generata dagli spezzoni di bombe
anglo-americane che l'avevano ferita. L'intervento ebbe luogo
nell'ambulatorio improvvisato nel postribolo del campo di
concentramento di Buchenwald. Il 24 precedente migliaia di fortezze
volanti partite da basi remote bombardarono a tappeto le Officine
Gustloff e i dintorni. Churchill, in visita a Napoli, voleva dare una
lezione alla Germania, già piegata dalla sconfitta inflittale dai
sovietici a Kursk. Nessuno immaginava che al bordo del campo vivesse la
figlia di Vittorio Emanuele III, catturata a Roma il 22 settembre 1943
per ordine di Hitler e lì detenuta dal 8 ottobre. “Povera foglia
frale...” la Principessa lasciò la vita terrena. Con Rescritto pubblicato il 1° agosto 2018 negli Acta Apostolicae
Sedis e nell'“Osservatore Romano”, papa Francesco ha mutato il titolo
n. 2667 del Catechismo della chiesa cattolica. La modifica risale
all'udienza concessa l'11 maggio scorso al prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede, Luis Ladaria, sempre in perfetta sintonia
con il pontefice. Il Catechismo pubblicato nel 1992 da papa Giovanni
Paolo II raccomandava alle “autorità” di impiegare “mezzi incruenti per
difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine
pubblico e la sicurezza delle persone”, sempre che risultassero
“sufficienti”. Diversamente si passava alle “vie di fatto”. Il nuovo
titolo 2267 insegna che “il ricorso alla pena di morte da parte della
legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta
adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche
se estremo, per la tutela del bene comune”, ma oggi “è sempre più viva
la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”,
neanche dopo aver commesso i crimini peggiori. Inoltre si è diffusa una
nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello
Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più
efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo
stesso tempo, “non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di
redimersi”, come accadrebbe se venissero giustiziati. Le carceri di
massima sicurezza non sono invenzioni recenti. Per capirlo, basta
visitare il “pozzetto” del forte di San Leo nel quale venne gettato il
conte di Cagliostro. Forse aiutato a morire a bastonate, ne uscì
cadavere e della sua salma si perse ogni traccia.
Con Rescritto pubblicato il 1° agosto 2018 negli Acta Apostolicae
Sedis e nell'“Osservatore Romano”, papa Francesco ha mutato il titolo
n. 2667 del Catechismo della chiesa cattolica. La modifica risale
all'udienza concessa l'11 maggio scorso al prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede, Luis Ladaria, sempre in perfetta sintonia
con il pontefice. Il Catechismo pubblicato nel 1992 da papa Giovanni
Paolo II raccomandava alle “autorità” di impiegare “mezzi incruenti per
difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine
pubblico e la sicurezza delle persone”, sempre che risultassero
“sufficienti”. Diversamente si passava alle “vie di fatto”. Il nuovo
titolo 2267 insegna che “il ricorso alla pena di morte da parte della
legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta
adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche
se estremo, per la tutela del bene comune”, ma oggi “è sempre più viva
la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”,
neanche dopo aver commesso i crimini peggiori. Inoltre si è diffusa una
nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello
Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più
efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo
stesso tempo, “non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di
redimersi”, come accadrebbe se venissero giustiziati. Le carceri di
massima sicurezza non sono invenzioni recenti. Per capirlo, basta
visitare il “pozzetto” del forte di San Leo nel quale venne gettato il
conte di Cagliostro. Forse aiutato a morire a bastonate, ne uscì
cadavere e della sua salma si perse ogni traccia.  Trecento
anni fa col Trattato di Londra del 2 agosto 1718 Vittorio Amedeo II,
duca di Savoia (1666-1732), fu riconosciuto Re di Sardegna, in cambio
della rinuncia alla corona di Sicilia, conferitagli con la pace di
Utrecht del 1713 e poi riconfermata con quella di Rastadt del 1714, a
conclusione della guerra di successione sul trono di Spagna. Venne così
ribadita la vocazione mediterranea della Casa di Savoia, iniziata con
l'annessione di Nizza. Il ripiegamento dalla Trinacria alla Sardegna
costituì una svolta per il re, per il Vecchio Piemonte e per l'intera
storia d'Italia, tanto più che, all'epoca, la Corsica era ancora sotto
dominio del genovese Banco di San Giorgio di Genova, una tra le mete
più agognate dai sovrani sabaudi. Lo stesso Vittorio Amedeo II, prima
di rassegnarsi al baratto (tutto in perdita) tra l'Isola del Sole e la
“petrosa” terra dei nuraghi aveva tentato di ottenere il ducato di
Parma e la Toscana col titolo di Re di Liguria. Per cogliere
l'importanza della svolta del 1718-1720, quando il sovrano prese
possesso effettivo della Sardegna, giova un panorama sintetico della
sua personalità e dei tempi procellosi nei quali visse.
Trecento
anni fa col Trattato di Londra del 2 agosto 1718 Vittorio Amedeo II,
duca di Savoia (1666-1732), fu riconosciuto Re di Sardegna, in cambio
della rinuncia alla corona di Sicilia, conferitagli con la pace di
Utrecht del 1713 e poi riconfermata con quella di Rastadt del 1714, a
conclusione della guerra di successione sul trono di Spagna. Venne così
ribadita la vocazione mediterranea della Casa di Savoia, iniziata con
l'annessione di Nizza. Il ripiegamento dalla Trinacria alla Sardegna
costituì una svolta per il re, per il Vecchio Piemonte e per l'intera
storia d'Italia, tanto più che, all'epoca, la Corsica era ancora sotto
dominio del genovese Banco di San Giorgio di Genova, una tra le mete
più agognate dai sovrani sabaudi. Lo stesso Vittorio Amedeo II, prima
di rassegnarsi al baratto (tutto in perdita) tra l'Isola del Sole e la
“petrosa” terra dei nuraghi aveva tentato di ottenere il ducato di
Parma e la Toscana col titolo di Re di Liguria. Per cogliere
l'importanza della svolta del 1718-1720, quando il sovrano prese
possesso effettivo della Sardegna, giova un panorama sintetico della
sua personalità e dei tempi procellosi nei quali visse.  Il 15 luglio 1938 “Il
Giornale d'Italia”, quotidiano romano da tempo asservito al regime di
partito unico, pubblicò il Manifesto degli scienziati sulla razza,
firmato il giorno prima, anniversario della Rivoluzione francese che
il 27 settembre 1791 aveva abolito ogni discriminazione degli
ebrei. Poco dopo il segretario del Partito Nazionale Fascista,
Achille Starace, vent'anni prima inutilmente iniziato alla loggia “La
Vedetta d'Italia”, aggiunse un elenco di “studiosi fascisti, docenti
nelle Università italiane” aderenti al “Manifesto” sotto l'egida di
Dino Alfieri, titolare del Min-cul-pop: abbreviazione dal suono
involontariamente goliardico della Cultura Popolare. Tra i firmatari
(alcuni fanatici, molti vanesi, taluni, come Sabato Visco, dal doppio
tuffo carpiato nel lago profondo di contraddizioni ancestrali) Nicola
Pende, studioso di vaglia, smentì di aver sottoscritto quello che,
anche a chi avesse gli occhi foderati di antisemitismo, risulta un
cumulo di castronerie.
Il 15 luglio 1938 “Il
Giornale d'Italia”, quotidiano romano da tempo asservito al regime di
partito unico, pubblicò il Manifesto degli scienziati sulla razza,
firmato il giorno prima, anniversario della Rivoluzione francese che
il 27 settembre 1791 aveva abolito ogni discriminazione degli
ebrei. Poco dopo il segretario del Partito Nazionale Fascista,
Achille Starace, vent'anni prima inutilmente iniziato alla loggia “La
Vedetta d'Italia”, aggiunse un elenco di “studiosi fascisti, docenti
nelle Università italiane” aderenti al “Manifesto” sotto l'egida di
Dino Alfieri, titolare del Min-cul-pop: abbreviazione dal suono
involontariamente goliardico della Cultura Popolare. Tra i firmatari
(alcuni fanatici, molti vanesi, taluni, come Sabato Visco, dal doppio
tuffo carpiato nel lago profondo di contraddizioni ancestrali) Nicola
Pende, studioso di vaglia, smentì di aver sottoscritto quello che,
anche a chi avesse gli occhi foderati di antisemitismo, risulta un
cumulo di castronerie.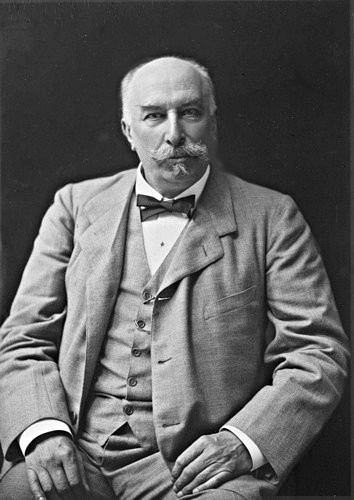 A 90 anni dalla morte (Cavour, 17
luglio 1928) Giovanni Giolitti rimane lo Statista eminente della Nuova
Italia. Il trascorrere del tempo lo rende anzi sempre più
paradigmatico. Di famiglia borghese, orfano di padre a un anno, crebbe
vegliato dalla madre, Enrichetta Plochiù, e dai suoi quattro fratelli
che, scapoli, investirono sulla sua formazione e sulla sua ascesa al
servizio dello Stato, impersonato dal Re, Carlo Alberto di
Savoia-Carignano (1831-1849). Due degli zii di “Gioanin” erano
magistrati (Melchior e Luigi); un terzo, Alessandro, venne promosso
generale per il valore mostrato nella battaglia di San Martino (21
giugno 1859); il quarto, Giuseppe, medico, fu ripetutamente eletto
deputato di Cavour al Parlamento subalpino dal 1848. Melchior, di ampie
vedute liberali, fu azionista del giornale di Camillo Cavour, “Il
Risorgimento”.
A 90 anni dalla morte (Cavour, 17
luglio 1928) Giovanni Giolitti rimane lo Statista eminente della Nuova
Italia. Il trascorrere del tempo lo rende anzi sempre più
paradigmatico. Di famiglia borghese, orfano di padre a un anno, crebbe
vegliato dalla madre, Enrichetta Plochiù, e dai suoi quattro fratelli
che, scapoli, investirono sulla sua formazione e sulla sua ascesa al
servizio dello Stato, impersonato dal Re, Carlo Alberto di
Savoia-Carignano (1831-1849). Due degli zii di “Gioanin” erano
magistrati (Melchior e Luigi); un terzo, Alessandro, venne promosso
generale per il valore mostrato nella battaglia di San Martino (21
giugno 1859); il quarto, Giuseppe, medico, fu ripetutamente eletto
deputato di Cavour al Parlamento subalpino dal 1848. Melchior, di ampie
vedute liberali, fu azionista del giornale di Camillo Cavour, “Il
Risorgimento”.  La “Lettera” del principe
Amedeo di Savoia, capo della Real Casa di Savoia e duca di Aosta, al
Corriere della Sera (“Aiutare l'Africa con passione. L'esempio del Duca
degli Abruzzi”, 26 giugno 2018, pag.24), invita a riflettere sulla
concezione e sulla percezione degli spazi afro-asiatici da parte della
Nuova Italia, da anni eluse a cospetto della incalzante irruzione di
milioni di “africani” e di “asiatici” sulle coste settentrionali del
Mediterraneo. Il tema, vastissimo e aggrovigliato, richiede
un'esposizione in prospettiva storica, con riferimento ineludibile ad
alcuni capisaldi della Costituzione vigente. Con l'articolo 2 “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...”.
A differenza degli articoli successivi, come rilevò anche
Marcello Pera, esso non si riferisce ai “cittadini italiani” ma all'
“uomo”. D'altronde, la Carta venne scritta e discussa nel 1946-47 e
datata Roma 27 dicembre 1947, dopo l'approvazione dello Statuto
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), aperto dall'enunciazione
di capisaldi etici di valore planetario. Essa entrò in vigore il 1°
gennaio 1948, l'anno nel quale “una tantum” l'Assemblea
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si radunò a Parigi per
approvare la Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo.
La “Lettera” del principe
Amedeo di Savoia, capo della Real Casa di Savoia e duca di Aosta, al
Corriere della Sera (“Aiutare l'Africa con passione. L'esempio del Duca
degli Abruzzi”, 26 giugno 2018, pag.24), invita a riflettere sulla
concezione e sulla percezione degli spazi afro-asiatici da parte della
Nuova Italia, da anni eluse a cospetto della incalzante irruzione di
milioni di “africani” e di “asiatici” sulle coste settentrionali del
Mediterraneo. Il tema, vastissimo e aggrovigliato, richiede
un'esposizione in prospettiva storica, con riferimento ineludibile ad
alcuni capisaldi della Costituzione vigente. Con l'articolo 2 “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...”.
A differenza degli articoli successivi, come rilevò anche
Marcello Pera, esso non si riferisce ai “cittadini italiani” ma all'
“uomo”. D'altronde, la Carta venne scritta e discussa nel 1946-47 e
datata Roma 27 dicembre 1947, dopo l'approvazione dello Statuto
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), aperto dall'enunciazione
di capisaldi etici di valore planetario. Essa entrò in vigore il 1°
gennaio 1948, l'anno nel quale “una tantum” l'Assemblea
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si radunò a Parigi per
approvare la Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo.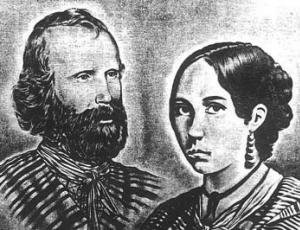 Torna Anita Garibaldi e ci ricorda che
l'Italia nacque patria della libertà, vessillo di Due Mondi in lento
cammino verso il “Sol dell'Avvenire”: diritti civili, parità di genere,
emancipazione dalla superstizione e dallo sfruttamento dei deboli,
rispetto delle Istituzioni non per feticismo ma perché sono patrimonio
comune dei cittadini. Il Risorgimento italiano fu non solo un esempio
ma un modello planetario. Una Profezia che per interpreti ebbe voci
universali, come l'Alessandro Manzoni di Le Pentecoste e Giuseppe
Verdi, che nel Nabucco elevò gli Ebrei a simbolo della Redenzione di
tutte le genti.
Torna Anita Garibaldi e ci ricorda che
l'Italia nacque patria della libertà, vessillo di Due Mondi in lento
cammino verso il “Sol dell'Avvenire”: diritti civili, parità di genere,
emancipazione dalla superstizione e dallo sfruttamento dei deboli,
rispetto delle Istituzioni non per feticismo ma perché sono patrimonio
comune dei cittadini. Il Risorgimento italiano fu non solo un esempio
ma un modello planetario. Una Profezia che per interpreti ebbe voci
universali, come l'Alessandro Manzoni di Le Pentecoste e Giuseppe
Verdi, che nel Nabucco elevò gli Ebrei a simbolo della Redenzione di
tutte le genti.  Le crisi odierne sono piccola cosa
rispetto a quelle di un secolo addietro. L'Europa e il mondo intero
erano col fucile sempre al piede. Altrettanto valeva per l'Italia, nel
maggio 1898 percorsa da moti insurrezionali divampati tra la Toscana e
la solitamente quieta Lombardia. A Pavia una manifestazione studentesca
fu repressa dai militari. Cadde ucciso anche il figlio di Giuseppe
Mussi, alto dignitario del Oriente Italiano, futuro senatore del regno.
A Milano andò peggio. Vi venne proclamato lo stato d'assedio. Il
generale Fiorenzo Bava Beccaris, fossanese, usò il pugno di ferro e
applicò il codice penale militare. Non esitò a chiudere associazioni
sospette e ad arrestare deputati dell'opposizione: repubblicani,
radicali, il socialista Filippo Turati e don Davide Albertario,
capofila della Democrazia cristiana, aspramente antiliberale, con punte
di antisemitismo fanatico. Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, da
quattro settimane alla guida del suo quarto governo in soli due anni,
con cambi continui di ministri nelle posizioni chiave, finalmente uscì
di scena. Dopo due ministri siciliani, lui e Francesco Crispi, travolto
nel marzo 1896 dalla rovinosa sconfitta inflitta al corpo italiano da
parte del negus d'Etiopia Menelik presso Adua, al governo
tornarono uomini dell'antico regno di Sardegna: il generale savoiardo
Luigi Girolamo Pelloux (due ministeri in due anni, 1898-1900) e
Giuseppe Saracco, di Bistagno (1900-1901), tuttora in attesa di una
biografia scientifica.
Le crisi odierne sono piccola cosa
rispetto a quelle di un secolo addietro. L'Europa e il mondo intero
erano col fucile sempre al piede. Altrettanto valeva per l'Italia, nel
maggio 1898 percorsa da moti insurrezionali divampati tra la Toscana e
la solitamente quieta Lombardia. A Pavia una manifestazione studentesca
fu repressa dai militari. Cadde ucciso anche il figlio di Giuseppe
Mussi, alto dignitario del Oriente Italiano, futuro senatore del regno.
A Milano andò peggio. Vi venne proclamato lo stato d'assedio. Il
generale Fiorenzo Bava Beccaris, fossanese, usò il pugno di ferro e
applicò il codice penale militare. Non esitò a chiudere associazioni
sospette e ad arrestare deputati dell'opposizione: repubblicani,
radicali, il socialista Filippo Turati e don Davide Albertario,
capofila della Democrazia cristiana, aspramente antiliberale, con punte
di antisemitismo fanatico. Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, da
quattro settimane alla guida del suo quarto governo in soli due anni,
con cambi continui di ministri nelle posizioni chiave, finalmente uscì
di scena. Dopo due ministri siciliani, lui e Francesco Crispi, travolto
nel marzo 1896 dalla rovinosa sconfitta inflitta al corpo italiano da
parte del negus d'Etiopia Menelik presso Adua, al governo
tornarono uomini dell'antico regno di Sardegna: il generale savoiardo
Luigi Girolamo Pelloux (due ministeri in due anni, 1898-1900) e
Giuseppe Saracco, di Bistagno (1900-1901), tuttora in attesa di una
biografia scientifica. Il “plebiscito” indetto da Di Maio e da
Salvini sul “Contratto per il governo del cambiamento” è un affare
loro, senza rilievo istituzionale. Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, non ha motivo di conferire alcun valore a una
pappolata dai contenuti cangianti, sottoscritto fra dubbi e riserve
mentali dai vertici scamiciati di Movimento 5 Stelle e Lega. Se
mai dovesse prenderla in considerazione, la dovrebbe affidare al vaglio
di costituzionalità. E lì comincerebbero i sette dolori, perché il
“Contratto” tutto è tranne che una proposta politica di ampio respiro.
È un pateracchio.
Il “plebiscito” indetto da Di Maio e da
Salvini sul “Contratto per il governo del cambiamento” è un affare
loro, senza rilievo istituzionale. Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, non ha motivo di conferire alcun valore a una
pappolata dai contenuti cangianti, sottoscritto fra dubbi e riserve
mentali dai vertici scamiciati di Movimento 5 Stelle e Lega. Se
mai dovesse prenderla in considerazione, la dovrebbe affidare al vaglio
di costituzionalità. E lì comincerebbero i sette dolori, perché il
“Contratto” tutto è tranne che una proposta politica di ampio respiro.
È un pateracchio. Alberto II Grimaldi, principe di Monaco, dal
2 maggio è cittadino onorario dei cinque comuni dell'Unione Montana
Alpi del Mare: Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.
Il sindaco di quest'ultimo comune, Giacomo Luigi Gaiotti, ha fatto da
capofila e da regista della complessa iniziativa, perseguita col
riserbo necessario per evitare che qualche grullo parlante guastasse la
festa, coronata da partecipe successo per le molte lezioni che se ne
traggono. Anzitutto, ribadire il legame tra i due versanti delle Alpi
può sembrare ovvio, ma nei fatti non lo è. Diciamo le cose come sono:
la costa da Genova a Nizza venne pensata come un continuum solo dopo
l'annessione della Superba da parte del regno di Sardegna, restaurato
nel 1814. Vittorio Emanuele I (1814-1821) e il manipolo di patrizi e
borghesi genovesi che scommisero sull'unità operosa tra Liguria e
Piemonte ripartirono da Augusto, quando l'Italia nord-occidentale
contava due regioni: la IX, “Liguria” (dal litorale alla destra del
Po), e l'XI “ Transpadania” (dalla sinistra del fiume al crinale
alpino). Lo Stato sabaudo da cinque secoli comprendeva la contea di
Nizza, perché così insegna la geografia: l'Italia non finisce a
Ventimiglia o a Roccabruna ma al Varo, a Nizza.
Alberto II Grimaldi, principe di Monaco, dal
2 maggio è cittadino onorario dei cinque comuni dell'Unione Montana
Alpi del Mare: Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.
Il sindaco di quest'ultimo comune, Giacomo Luigi Gaiotti, ha fatto da
capofila e da regista della complessa iniziativa, perseguita col
riserbo necessario per evitare che qualche grullo parlante guastasse la
festa, coronata da partecipe successo per le molte lezioni che se ne
traggono. Anzitutto, ribadire il legame tra i due versanti delle Alpi
può sembrare ovvio, ma nei fatti non lo è. Diciamo le cose come sono:
la costa da Genova a Nizza venne pensata come un continuum solo dopo
l'annessione della Superba da parte del regno di Sardegna, restaurato
nel 1814. Vittorio Emanuele I (1814-1821) e il manipolo di patrizi e
borghesi genovesi che scommisero sull'unità operosa tra Liguria e
Piemonte ripartirono da Augusto, quando l'Italia nord-occidentale
contava due regioni: la IX, “Liguria” (dal litorale alla destra del
Po), e l'XI “ Transpadania” (dalla sinistra del fiume al crinale
alpino). Lo Stato sabaudo da cinque secoli comprendeva la contea di
Nizza, perché così insegna la geografia: l'Italia non finisce a
Ventimiglia o a Roccabruna ma al Varo, a Nizza.