 Dal declino dell'Impero Romano non c'è nella storia d’Italia un momento esente da interferenze straniere: scorrerie, invasioni, dominio di sovrani esteri e del papa, nemico storico della sua indipendenza. Per quanto ovvio, questo tragico passato va ricordato perché dilaga un allarme esagerato: gli italiani odierni sarebbero esposti a interferenze dirette o indirette di imbonitori d'Oltralpe, come non bastassero quelli nostrani.
Dal declino dell'Impero Romano non c'è nella storia d’Italia un momento esente da interferenze straniere: scorrerie, invasioni, dominio di sovrani esteri e del papa, nemico storico della sua indipendenza. Per quanto ovvio, questo tragico passato va ricordato perché dilaga un allarme esagerato: gli italiani odierni sarebbero esposti a interferenze dirette o indirette di imbonitori d'Oltralpe, come non bastassero quelli nostrani. “Eja, eja, eja, Alalà!” fu a lungo il motto anche del torinese Giacomo Treves, personalità emblematica dell'aggrovigliata storia d'Italia dall'età emanuelino-giolittiana alla seconda guerra mondiale. Come la generalità degli ebrei dell'Ottocento, egli vide nell'unificazione italiana l'emancipazione definitiva del suo popolo da vessazioni ancora imperversanti in tutta l'Europa continentale, dalla penisola iberica all'impero di Russia, a inizio Novecento teatro di pogrom (del resto anche Stalin perseguitò gli ebrei, molti cui esponenti fece assassinare, da Kamenev a Trotzky).
“Eja, eja, eja, Alalà!” fu a lungo il motto anche del torinese Giacomo Treves, personalità emblematica dell'aggrovigliata storia d'Italia dall'età emanuelino-giolittiana alla seconda guerra mondiale. Come la generalità degli ebrei dell'Ottocento, egli vide nell'unificazione italiana l'emancipazione definitiva del suo popolo da vessazioni ancora imperversanti in tutta l'Europa continentale, dalla penisola iberica all'impero di Russia, a inizio Novecento teatro di pogrom (del resto anche Stalin perseguitò gli ebrei, molti cui esponenti fece assassinare, da Kamenev a Trotzky). 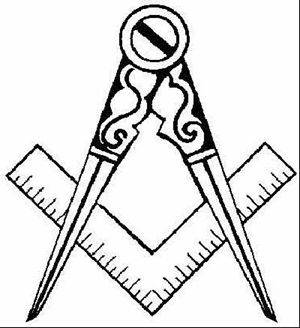 Avviso alla Commissione parlamentare d'inchiesta su Mafia e massoneria: se in Italia non esiste una legge a “tutela del nome”, la colpa non è dei massoni ma della perdurante distrazione di massa dei “politici” che si pascono di pappolate sui “segreti massonici”. L'unico vero complotto in atto è quello contro la libertà d'associazione. Vediamo perché.
Avviso alla Commissione parlamentare d'inchiesta su Mafia e massoneria: se in Italia non esiste una legge a “tutela del nome”, la colpa non è dei massoni ma della perdurante distrazione di massa dei “politici” che si pascono di pappolate sui “segreti massonici”. L'unico vero complotto in atto è quello contro la libertà d'associazione. Vediamo perché. Nella Tradizione il “Divino Maestro” è uno solo: il Messia, figlio unigenito di Dio, a lui unito nello Spirito Santo: la Trinità, ignota alla generalità dei sedicenti cristiani. Solo tra gli Evangelisti, Luca scrisse della formazione di Gesù (2, 41-52). Narrò che, condotto come ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, Gesù dodicenne (età puberale) si sottrasse alla sorveglianza di Maria e Giuseppe. I genitori lo ritrovarono tre giorni dopo (cifra simbolica), seduto nel Tempio, in mezzo ai “dottori”, intento ad ascoltarli e a interrogarli. Quelli che lo udivano erano stupefatti della sua intelligenza e delle sue risposte. Alla madre, che gli manifestava l'angoscia provata, Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose di mio Padre?”. Si riferiva al Padre Celeste ma, osserva l'Evangelista Luca, “essi non compresero ciò che egli aveva detto”. L'“adolescente” non insuperbì affatto: “scese con loro e tornò a Nazaret ed era sottomesso ad essi”. Crebbe in sapienza e statura e grazia presso Dio e gli uomini”. Silente sino al trentesimo anno.
Nella Tradizione il “Divino Maestro” è uno solo: il Messia, figlio unigenito di Dio, a lui unito nello Spirito Santo: la Trinità, ignota alla generalità dei sedicenti cristiani. Solo tra gli Evangelisti, Luca scrisse della formazione di Gesù (2, 41-52). Narrò che, condotto come ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, Gesù dodicenne (età puberale) si sottrasse alla sorveglianza di Maria e Giuseppe. I genitori lo ritrovarono tre giorni dopo (cifra simbolica), seduto nel Tempio, in mezzo ai “dottori”, intento ad ascoltarli e a interrogarli. Quelli che lo udivano erano stupefatti della sua intelligenza e delle sue risposte. Alla madre, che gli manifestava l'angoscia provata, Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose di mio Padre?”. Si riferiva al Padre Celeste ma, osserva l'Evangelista Luca, “essi non compresero ciò che egli aveva detto”. L'“adolescente” non insuperbì affatto: “scese con loro e tornò a Nazaret ed era sottomesso ad essi”. Crebbe in sapienza e statura e grazia presso Dio e gli uomini”. Silente sino al trentesimo anno.  Dalle 15 del 15 dicembre 2017 la Salma di Elena di Savoia, riposa nella Cappella di San Bernardo del Santuario-Basilica di Vicoforte (Cuneo), accanto alle spoglie di Carlo Emanuele I di Savoia, il Duca che nel 1596 volle la costruzione del maestoso Mausoleo dei Savoia, capolavoro di Ascanio Vitozzi e di Francesco Gallo.
Dalle 15 del 15 dicembre 2017 la Salma di Elena di Savoia, riposa nella Cappella di San Bernardo del Santuario-Basilica di Vicoforte (Cuneo), accanto alle spoglie di Carlo Emanuele I di Savoia, il Duca che nel 1596 volle la costruzione del maestoso Mausoleo dei Savoia, capolavoro di Ascanio Vitozzi e di Francesco Gallo. Il mondo è sull'orlo del “lago di fuoco” predetto dall'Apocalisse? La Guerra si avvicina. Non perché lo dica Donald Trump. Lo si percepisce dalla cruda sequenza dei fatti. Senza un intervento preventivo, in Estremo Oriente crollano i già precari equilibri. Il Giappone non può rimanere spettatore inerte, disarmato e con l'incubo di missili con testate atomiche nelle mani di un nemico millenario quale la Corea. Altrettanto vale per la Cina. Si sa che dal 1945 le guerre non si dichiarano. Si fanno. Chi è vecchio abbastanza da ricordare i bombardamenti del 1940-1945 sull'Italia ha in memoria il lamento delle sirene, le corse verso i rifugi, gli schianti: sa per esperienza personale che cos'era la guerra quando ancora essa era “mite”. Il Piemonte e la Liguria furono i primi a conoscerli nel giugno 1940. Genova e Torino ne vennero devastate ripetutamente. Dopo settant'anni di distrazione, la Guerra bussa alle porte. Ed è di gran lunga peggiore e “amorale” di quelle d'antan. Gli italiani hanno una certa riluttanza a misurarsi con la realtà. Sbagliano il nome di Gerusalemme contando che lo Stato di Israele non se ne accorga. Scoprono i conflitti balcanici di un quarto di secolo addietro perché un generale croato si avvelena respingendo la legittimità etica del tribunale internazionale che lo condanna. Assecondando la dolciastra favola corrente, gli italiani spalmano la “domenica calcistica” su quattro giorni e a novembre spasimano per il festival della canzone del febbraio venturo..., felicemente dimentichi della storia. Che perciò va ricordata, nella sua ruvidità.
Il mondo è sull'orlo del “lago di fuoco” predetto dall'Apocalisse? La Guerra si avvicina. Non perché lo dica Donald Trump. Lo si percepisce dalla cruda sequenza dei fatti. Senza un intervento preventivo, in Estremo Oriente crollano i già precari equilibri. Il Giappone non può rimanere spettatore inerte, disarmato e con l'incubo di missili con testate atomiche nelle mani di un nemico millenario quale la Corea. Altrettanto vale per la Cina. Si sa che dal 1945 le guerre non si dichiarano. Si fanno. Chi è vecchio abbastanza da ricordare i bombardamenti del 1940-1945 sull'Italia ha in memoria il lamento delle sirene, le corse verso i rifugi, gli schianti: sa per esperienza personale che cos'era la guerra quando ancora essa era “mite”. Il Piemonte e la Liguria furono i primi a conoscerli nel giugno 1940. Genova e Torino ne vennero devastate ripetutamente. Dopo settant'anni di distrazione, la Guerra bussa alle porte. Ed è di gran lunga peggiore e “amorale” di quelle d'antan. Gli italiani hanno una certa riluttanza a misurarsi con la realtà. Sbagliano il nome di Gerusalemme contando che lo Stato di Israele non se ne accorga. Scoprono i conflitti balcanici di un quarto di secolo addietro perché un generale croato si avvelena respingendo la legittimità etica del tribunale internazionale che lo condanna. Assecondando la dolciastra favola corrente, gli italiani spalmano la “domenica calcistica” su quattro giorni e a novembre spasimano per il festival della canzone del febbraio venturo..., felicemente dimentichi della storia. Che perciò va ricordata, nella sua ruvidità. Sarebbe facile se per fare una “nazione” bastassero la bandiera e un canto. Fatto è che oltre la “nazione”, vi è lo Stato. Quando il soldo valeva cinque centesimi, gli anziani dicevano che spesso ne mancava ancora uno per fare la lira, il minimo per “cominciare”. Quell'inezia faceva la differenza. Così è del rapporto tra due Entità del tutto diverse: la nazione (i diciannove centesimi) e lo Stato (la lira). La nazione era e rimane un’identità storica percepibile per somme e diversità. Lo Stato è la forma giuridica accettata dalla Comunità internazionale. La nazione è una bellezza. Lo Stato è la certezza. Ogni Stato europeo, antico o nuovo che sia, ha nel proprio ambito cittadini in larga maggioranza appartenenti alla “nazione” storicamente precipua e/o egemone, ma anche molti altri che invece non lo sono affatto e talora agognano a confluire in altri Paesi o addirittura a far parte per se stessi. La deflagrazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) ha impresso nel magma geopolitico dal Caspio all'Europa orientale sommovimenti non ancora assestati nel quadro internazionale (il Kossovo esiste solo per chi lo riconosce) né metabolizzati dalla cultura politica, in particolare la nostrana, che fa delle elezioni a Ostia la sfida tra il Male e il Bene, tra la Luce e le Tenebre. Provincialismo perpetuo di un Paese impastato di municipalismi, faide di quartiere beghe da balconi. In tanta parte d'Europa gli “Stati” rimangono lontani dal coincidere con le “nazioni”: una coincidenza pressoché impossibile nelle numerose zone mistilingue e plurietniche non solo della Vecchia Europa (che già tanto assilla) ma dell'intero pianeta, popolato di “tribù”.
Sarebbe facile se per fare una “nazione” bastassero la bandiera e un canto. Fatto è che oltre la “nazione”, vi è lo Stato. Quando il soldo valeva cinque centesimi, gli anziani dicevano che spesso ne mancava ancora uno per fare la lira, il minimo per “cominciare”. Quell'inezia faceva la differenza. Così è del rapporto tra due Entità del tutto diverse: la nazione (i diciannove centesimi) e lo Stato (la lira). La nazione era e rimane un’identità storica percepibile per somme e diversità. Lo Stato è la forma giuridica accettata dalla Comunità internazionale. La nazione è una bellezza. Lo Stato è la certezza. Ogni Stato europeo, antico o nuovo che sia, ha nel proprio ambito cittadini in larga maggioranza appartenenti alla “nazione” storicamente precipua e/o egemone, ma anche molti altri che invece non lo sono affatto e talora agognano a confluire in altri Paesi o addirittura a far parte per se stessi. La deflagrazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) ha impresso nel magma geopolitico dal Caspio all'Europa orientale sommovimenti non ancora assestati nel quadro internazionale (il Kossovo esiste solo per chi lo riconosce) né metabolizzati dalla cultura politica, in particolare la nostrana, che fa delle elezioni a Ostia la sfida tra il Male e il Bene, tra la Luce e le Tenebre. Provincialismo perpetuo di un Paese impastato di municipalismi, faide di quartiere beghe da balconi. In tanta parte d'Europa gli “Stati” rimangono lontani dal coincidere con le “nazioni”: una coincidenza pressoché impossibile nelle numerose zone mistilingue e plurietniche non solo della Vecchia Europa (che già tanto assilla) ma dell'intero pianeta, popolato di “tribù”. La classe dirigente di un grande Paese non è frutto di improvvisazione. Gli “uomini di Stato” non nascono per germinazione spontanea. La loro formazione richiede tempi lunghi: intere generazioni. La nuova legge elettorale propizia la discesa in campo di valori veri (spesso avanti negli anni, come si vide in Italia nel 1943-1948) anziché meri procacciatori di voti. I primi durano nel lungo periodo, sono i pilastri portanti della politica perché nutriti di solida cultura (ne fu esempio Sergio Paronetto, biografato da Tiziano Torresi in un robusto saggio edito da il Mulino e candidato al Premio Acqui Storia 2017). Gli altri sono randagi. Vagano con i loro pacchi di consensi, sempre più inaffidabili e a rischio di putrefazione. Nel frattempo, per quanto aleatori, contagiano chi li ha presi in carico, nell'illusione di trarne beneficio durevole.
La classe dirigente di un grande Paese non è frutto di improvvisazione. Gli “uomini di Stato” non nascono per germinazione spontanea. La loro formazione richiede tempi lunghi: intere generazioni. La nuova legge elettorale propizia la discesa in campo di valori veri (spesso avanti negli anni, come si vide in Italia nel 1943-1948) anziché meri procacciatori di voti. I primi durano nel lungo periodo, sono i pilastri portanti della politica perché nutriti di solida cultura (ne fu esempio Sergio Paronetto, biografato da Tiziano Torresi in un robusto saggio edito da il Mulino e candidato al Premio Acqui Storia 2017). Gli altri sono randagi. Vagano con i loro pacchi di consensi, sempre più inaffidabili e a rischio di putrefazione. Nel frattempo, per quanto aleatori, contagiano chi li ha presi in carico, nell'illusione di trarne beneficio durevole. “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voialtri invece ne fate una spelonca di briganti!”. Lo scrissero gli Evangelisti Matteo (21, 13), Marco e Luca, con identiche parole. Matteo aggiunse: “Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che siete simili a sepolcri imbiancati: sono belli all'apparenza, ma dentro sono pieni di ossa di morti e d'ogni immondezza… di ipocrisia e di iniquità”. È il ritratto di tante scuole italiane, da decenni alla deriva. L'ultima seria legge sulla scuola è quella varata nel 1923 da Giovanni Gentile, ministro della Pubblica istruzione nel governo di coalizione nazionale in carica dal 31 ottobre 1922, sulla traccia di quella approntata da Benedetto Croce due anni prima col governo Giolitti. Scuola è disciplina: studio, preparazione e applicazione, come la Scuola dell'Esercito all'Arsenale di Torino, comandata del gen. Claudio Berto. Scuola è educazione dalla ferinità all'umanità, attraverso lungo tirocinio. È palestra (ginnasio): il dominio di sé si raggiunge con impegno e sacrificio.
“La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voialtri invece ne fate una spelonca di briganti!”. Lo scrissero gli Evangelisti Matteo (21, 13), Marco e Luca, con identiche parole. Matteo aggiunse: “Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che siete simili a sepolcri imbiancati: sono belli all'apparenza, ma dentro sono pieni di ossa di morti e d'ogni immondezza… di ipocrisia e di iniquità”. È il ritratto di tante scuole italiane, da decenni alla deriva. L'ultima seria legge sulla scuola è quella varata nel 1923 da Giovanni Gentile, ministro della Pubblica istruzione nel governo di coalizione nazionale in carica dal 31 ottobre 1922, sulla traccia di quella approntata da Benedetto Croce due anni prima col governo Giolitti. Scuola è disciplina: studio, preparazione e applicazione, come la Scuola dell'Esercito all'Arsenale di Torino, comandata del gen. Claudio Berto. Scuola è educazione dalla ferinità all'umanità, attraverso lungo tirocinio. È palestra (ginnasio): il dominio di sé si raggiunge con impegno e sacrificio.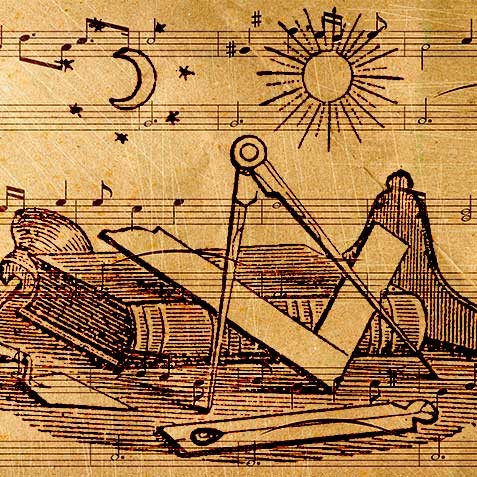 Non lasciamo passare in sordina un 150° memorabile: l'elezione della contessa Giulia Caracciolo Cigala a venerabile della loggia massonica “Vessillo di Carità e Anita”, costituita a Napoli tre anni prima. Nel 1867 le “sorelle massone” si prodigarono nell'ultima spedizione di Giuseppe Garibaldi per debellare il papa-re e fare di Roma la capitale d'Italia. L'impresa finì male, a Mentana, il 3 novembre (verrà ricordato dalle “istituzioni”?). La tragedia fu l'alto numero di garibaldini abbattuti con fucili di precisione dai francesi accorsi in aiuto degli zuavi pontifici (150 morti e 240 feriti, contro 2 caduti francesi e 30 zuavi pontifici) e dei 1.600 prigionieri (incarcerati a Roma in pessime condizioni), ma soprattutto il completo fallimento politico del progetto. Garibaldi contava sull'insurrezione dei romani, che invece non mossero paglia. La colonna di volontari mandata in loro aiuto fu annientata a Villa Glori. Enrico Cairoli cadde nello scontro. Suo fratello Giovanni morì per le ferite. Garibaldi aveva circa 6.000 uomini. Nel bel mezzo della battaglia una buona metà lasciò il combattimento perché sognava Roma capitale della Repubblica universale ispirata da Giuseppe Mazzini mentre il Generale voleva unirla alla corona di Vittorio Emanuele II re costituzionale.
Non lasciamo passare in sordina un 150° memorabile: l'elezione della contessa Giulia Caracciolo Cigala a venerabile della loggia massonica “Vessillo di Carità e Anita”, costituita a Napoli tre anni prima. Nel 1867 le “sorelle massone” si prodigarono nell'ultima spedizione di Giuseppe Garibaldi per debellare il papa-re e fare di Roma la capitale d'Italia. L'impresa finì male, a Mentana, il 3 novembre (verrà ricordato dalle “istituzioni”?). La tragedia fu l'alto numero di garibaldini abbattuti con fucili di precisione dai francesi accorsi in aiuto degli zuavi pontifici (150 morti e 240 feriti, contro 2 caduti francesi e 30 zuavi pontifici) e dei 1.600 prigionieri (incarcerati a Roma in pessime condizioni), ma soprattutto il completo fallimento politico del progetto. Garibaldi contava sull'insurrezione dei romani, che invece non mossero paglia. La colonna di volontari mandata in loro aiuto fu annientata a Villa Glori. Enrico Cairoli cadde nello scontro. Suo fratello Giovanni morì per le ferite. Garibaldi aveva circa 6.000 uomini. Nel bel mezzo della battaglia una buona metà lasciò il combattimento perché sognava Roma capitale della Repubblica universale ispirata da Giuseppe Mazzini mentre il Generale voleva unirla alla corona di Vittorio Emanuele II re costituzionale. Cent'anni dopo diciamo la verità: Caporetto non fu affatto “Caporetto”, “la madre di tutte le disfatte”, la condanna dell'Italia a sentirsi “bella e perduta”, da sempre e per sempre. Chi lo scrisse e lo ripete è disinformato o in malafede. Tanti manuali echeggianti il Sessantottismo perenne, ripetono la litania di un'Italia perpetuamente perdente: Custoza (1848 e 1866), Novara (1849), Lissa (1866), Adua (1896), Sciara-Sciat e poi, appunto, la ritirata dall'Isonzo al Piave (24 ottobre-8 novembre 1917) e, s'intende, l'8 settembre 1943, la “fuga di Brindisi”, ecc. ecc. Così l'Italia viene avvolta in lugubri panni anziché nel tricolore.
Cent'anni dopo diciamo la verità: Caporetto non fu affatto “Caporetto”, “la madre di tutte le disfatte”, la condanna dell'Italia a sentirsi “bella e perduta”, da sempre e per sempre. Chi lo scrisse e lo ripete è disinformato o in malafede. Tanti manuali echeggianti il Sessantottismo perenne, ripetono la litania di un'Italia perpetuamente perdente: Custoza (1848 e 1866), Novara (1849), Lissa (1866), Adua (1896), Sciara-Sciat e poi, appunto, la ritirata dall'Isonzo al Piave (24 ottobre-8 novembre 1917) e, s'intende, l'8 settembre 1943, la “fuga di Brindisi”, ecc. ecc. Così l'Italia viene avvolta in lugubri panni anziché nel tricolore. Ottone II di Sassonia, “Imperator Romanorum”, spese la vita per liberare l'Italia dagli islamici. Li cacciò da Taranto, ma fu sconfitto a Capo Cotrone (982). Salvò la vita a stento. Quasi non ne parla James Bryce nel poderoso volume “Il Sacro Romano Impero” (un “classico” cresciuto lungo mezzo secolo di studi, tra il 1860 e il 1904), curato da Paolo Mazzeranghi per D'Ettoris Editori. Eppure tanta parte della storia d'Europa è lì: nella lotta millenaria tra Carlomagno e Maometto, come scrisse Henri Pirenne.
Ottone II di Sassonia, “Imperator Romanorum”, spese la vita per liberare l'Italia dagli islamici. Li cacciò da Taranto, ma fu sconfitto a Capo Cotrone (982). Salvò la vita a stento. Quasi non ne parla James Bryce nel poderoso volume “Il Sacro Romano Impero” (un “classico” cresciuto lungo mezzo secolo di studi, tra il 1860 e il 1904), curato da Paolo Mazzeranghi per D'Ettoris Editori. Eppure tanta parte della storia d'Europa è lì: nella lotta millenaria tra Carlomagno e Maometto, come scrisse Henri Pirenne.  “O tempora, o mores!”. In Gran Bretagna viene proposto di datare gli anni non “prima” o “dopo” Cristo ma da una “Era Comune”: da un “anno uno”, che comunque dovrebbe essere, salvo ripensamenti, quello (convenzionale) della nascita di Gesù Cristo Redentore. Cambiare il 2017 in chissà quale altro comporterebbe di introdurre una datazione nuova in tutti i "documenti", non solo nei siti telematici ma anche nelle banche, nell'efficacia dei contratti, dalla vendita di un biglietto aereo a impegni finanziari, ad atti notarili e via continuando. Una catastrofe. Ecco allora la soluzione più semplice per accontentare multiculturalisti d'accatto, ormai ginocchioni dinnanzi alle invasioni: cancellare l'Avvento. Così le moltitudini di eurozeri non si sentiranno più offesi dal riferimento a Cristo, falso messia per alcuni, uno dei tanti profeti per altri, un sovversivo per chi ne chiese la crocefissione al Proconsole romano Ponzio Pilato, che se ne lavò le mani e lasciò fare. "Un poco di buono", insomma.
“O tempora, o mores!”. In Gran Bretagna viene proposto di datare gli anni non “prima” o “dopo” Cristo ma da una “Era Comune”: da un “anno uno”, che comunque dovrebbe essere, salvo ripensamenti, quello (convenzionale) della nascita di Gesù Cristo Redentore. Cambiare il 2017 in chissà quale altro comporterebbe di introdurre una datazione nuova in tutti i "documenti", non solo nei siti telematici ma anche nelle banche, nell'efficacia dei contratti, dalla vendita di un biglietto aereo a impegni finanziari, ad atti notarili e via continuando. Una catastrofe. Ecco allora la soluzione più semplice per accontentare multiculturalisti d'accatto, ormai ginocchioni dinnanzi alle invasioni: cancellare l'Avvento. Così le moltitudini di eurozeri non si sentiranno più offesi dal riferimento a Cristo, falso messia per alcuni, uno dei tanti profeti per altri, un sovversivo per chi ne chiese la crocefissione al Proconsole romano Ponzio Pilato, che se ne lavò le mani e lasciò fare. "Un poco di buono", insomma.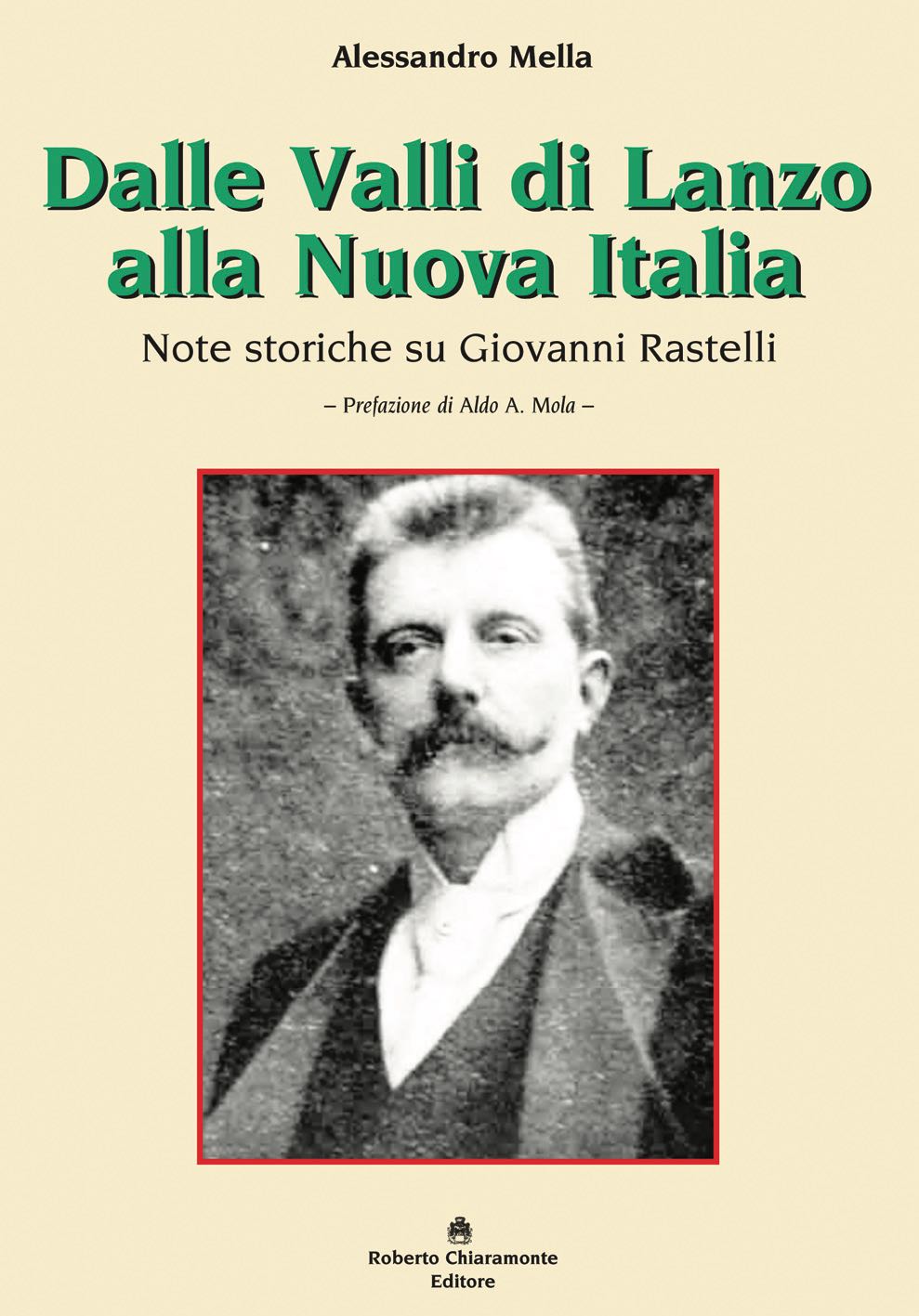 Il Parlamento, una volta tanto all'unanimità, ha stanziato cento milioni per salvare dal declino quasi 5.000 “piccoli comuni”. Sono coriandoli, rispetto ai bisogni effettivi, agli sprechi permanenti, a leggi, leggine e scaricabarile che paralizzano la vita pubblica e privata di un Paese nel conflitto tra Stato, Regioni e Tar, salva riserva di ricorso a Corti europee e internazionali. Il problema numero uno dell'Italia odierna è il groviglio dei “poteri”. Chi vorrebbe investire rinuncia a farlo in un Paese ove la proprietà è considerata un furto (come insegnava un certo Jean-Jacques Rousseau) e chi ha qualche risparmio vive sotto la scure di un fisco rapace che s'intrufola nella vita privata oltre ogni decenza.
Il Parlamento, una volta tanto all'unanimità, ha stanziato cento milioni per salvare dal declino quasi 5.000 “piccoli comuni”. Sono coriandoli, rispetto ai bisogni effettivi, agli sprechi permanenti, a leggi, leggine e scaricabarile che paralizzano la vita pubblica e privata di un Paese nel conflitto tra Stato, Regioni e Tar, salva riserva di ricorso a Corti europee e internazionali. Il problema numero uno dell'Italia odierna è il groviglio dei “poteri”. Chi vorrebbe investire rinuncia a farlo in un Paese ove la proprietà è considerata un furto (come insegnava un certo Jean-Jacques Rousseau) e chi ha qualche risparmio vive sotto la scure di un fisco rapace che s'intrufola nella vita privata oltre ogni decenza.  Il 20 settembre Camillo Cavour è stato rievocato a Santena. Una lapide ricorda che il Castello fu elevato a Monumento nazionale, come la Casa di Vittorio Alfieri ad Asti e altri tre edifici storici in Piemonte. “Monumento” non significa reliquia inerte, ma “ammonimento”: insegnamento vivo e attuale. Lo hanno ricordato il presidente della Fondazione Cavour, Nerio Nesi, “testimone del tempo” al Premio Acqui Storia (sabato 21 ottobre all'“Ariston”, nella città della Bollente), Luigi La Spina e gli altri relatori, concordi che il “politico vero” è una persona “competente”, che assume il ruolo pubblico conscio della responsabilità dinnanzi ai cittadini, al Paese e, diciamolo, alla Storia. Sennò è meglio per tutti che continui a fare il suo mestiere, se ne ha uno. Da ragazzino Cavour annotò che avrebbe presieduto il governo d'Italia. Ci arrivò. Studiando, viaggiando all'estero, progettando, sperimentando di persona il futuro programma economico dell'Italia nascente. Sulla fine del 1850 Cavour assunse il ministero dell'Agricoltura, vacante per la morte di Pietro de Rossi di Santa Rosa (gli furono negati i conforti religiosi perché non ritrattò il voto a favore delle leggi Siccardi, che parificarono il clero dinnanzi alle leggi: quella era la chiesa di Roma). Cavour aveva alle spalle le cure dedicate alle terre di famiglia a Grinzane e a Leri, trasformate in aziende agricole d'avanguardia nella viti-vinicoltura e nella risicoltura. Per migliorare la concimazione mentre per motivi bellici dal Cile non arrivava il guano ordinariamente utilizzato promosse a San Pier d'Arena il primo stabilimento per la produzione di fertilizzanti chimici. Seguì con attenzione i Congressi degli Scienziati Italiani ideati da Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino. Era l'Italia di Ascanio Sobrero, inventore della nitroglicerina, un Paese geniale e competitivo perché si fondava, appunto, sulla competenza della classe dirigente: non una manciata di ambiziosi, arroganti e arruffoni ma migliaia di studiosi collegati l'uno con l'altro e a continuo contatto con l'estero per il progresso civile dei connazionali.
Il 20 settembre Camillo Cavour è stato rievocato a Santena. Una lapide ricorda che il Castello fu elevato a Monumento nazionale, come la Casa di Vittorio Alfieri ad Asti e altri tre edifici storici in Piemonte. “Monumento” non significa reliquia inerte, ma “ammonimento”: insegnamento vivo e attuale. Lo hanno ricordato il presidente della Fondazione Cavour, Nerio Nesi, “testimone del tempo” al Premio Acqui Storia (sabato 21 ottobre all'“Ariston”, nella città della Bollente), Luigi La Spina e gli altri relatori, concordi che il “politico vero” è una persona “competente”, che assume il ruolo pubblico conscio della responsabilità dinnanzi ai cittadini, al Paese e, diciamolo, alla Storia. Sennò è meglio per tutti che continui a fare il suo mestiere, se ne ha uno. Da ragazzino Cavour annotò che avrebbe presieduto il governo d'Italia. Ci arrivò. Studiando, viaggiando all'estero, progettando, sperimentando di persona il futuro programma economico dell'Italia nascente. Sulla fine del 1850 Cavour assunse il ministero dell'Agricoltura, vacante per la morte di Pietro de Rossi di Santa Rosa (gli furono negati i conforti religiosi perché non ritrattò il voto a favore delle leggi Siccardi, che parificarono il clero dinnanzi alle leggi: quella era la chiesa di Roma). Cavour aveva alle spalle le cure dedicate alle terre di famiglia a Grinzane e a Leri, trasformate in aziende agricole d'avanguardia nella viti-vinicoltura e nella risicoltura. Per migliorare la concimazione mentre per motivi bellici dal Cile non arrivava il guano ordinariamente utilizzato promosse a San Pier d'Arena il primo stabilimento per la produzione di fertilizzanti chimici. Seguì con attenzione i Congressi degli Scienziati Italiani ideati da Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino. Era l'Italia di Ascanio Sobrero, inventore della nitroglicerina, un Paese geniale e competitivo perché si fondava, appunto, sulla competenza della classe dirigente: non una manciata di ambiziosi, arroganti e arruffoni ma migliaia di studiosi collegati l'uno con l'altro e a continuo contatto con l'estero per il progresso civile dei connazionali. Senza un'“idea” forte, un progetto, un “mito” non si va in alcuna direzione e non si costruisce nulla. Lo si scopre quando ci si mette in gioco. Un Paese, una città, una persona... non valgono perché lo dicono altri, ma di per sé. Ne sono consapevoli e sanno dimostrarlo. Sono quarantasei le città d'Italia candidate a Capitale della Cultura 2020. Tre del Piemonte (Asti, Casale Monferrato e Cuneo), nessuna della Liguria né della Valle d'Aosta. Entrare nelle dieci finaliste vuol dire richiamare i fari dell'attenzione non solo nazionale. La designazione finale, entro il gennaio 2018, assicura fondi e al tempo stesso comporta oneri. Chi prevarrà? I criteri per la selezione del vincitore sono quelli oggi in voga. Per “cultura” la gara non intende le “scienze” ma un miscuglio di creatività, innovazione, sviluppo economico individuale e collettivo, valutato su parametri molto opinabili. Gareggiare con Agropoli, Bellano, Bitonto, Lanciano, Pieve di Cadore, Telese Terme, Tramezzina e Villa Castelli apre spiragli di successo alle città piemontesi. Però esse debbono misurarsi anche con Agrigento (la Valle dei Templi e l'olivo cinerario di Pirandello), Capaccio Paestum (altri incantevoli Templi della Magna Grecia), Caserta (una tra le Regge più belle d'Europa), Catania… sino a Parma e Piacenza, Salerno (dalla celebre Università fridericiana) e Siracusa, cioè la storia millenaria greco-romana.
Senza un'“idea” forte, un progetto, un “mito” non si va in alcuna direzione e non si costruisce nulla. Lo si scopre quando ci si mette in gioco. Un Paese, una città, una persona... non valgono perché lo dicono altri, ma di per sé. Ne sono consapevoli e sanno dimostrarlo. Sono quarantasei le città d'Italia candidate a Capitale della Cultura 2020. Tre del Piemonte (Asti, Casale Monferrato e Cuneo), nessuna della Liguria né della Valle d'Aosta. Entrare nelle dieci finaliste vuol dire richiamare i fari dell'attenzione non solo nazionale. La designazione finale, entro il gennaio 2018, assicura fondi e al tempo stesso comporta oneri. Chi prevarrà? I criteri per la selezione del vincitore sono quelli oggi in voga. Per “cultura” la gara non intende le “scienze” ma un miscuglio di creatività, innovazione, sviluppo economico individuale e collettivo, valutato su parametri molto opinabili. Gareggiare con Agropoli, Bellano, Bitonto, Lanciano, Pieve di Cadore, Telese Terme, Tramezzina e Villa Castelli apre spiragli di successo alle città piemontesi. Però esse debbono misurarsi anche con Agrigento (la Valle dei Templi e l'olivo cinerario di Pirandello), Capaccio Paestum (altri incantevoli Templi della Magna Grecia), Caserta (una tra le Regge più belle d'Europa), Catania… sino a Parma e Piacenza, Salerno (dalla celebre Università fridericiana) e Siracusa, cioè la storia millenaria greco-romana. La disputa sulla “Marcia su Roma” programmata da Forza Nuova per il prossimo 28 ottobre salirà ancora di tono, anche per le improvvide dichiarazioni del sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che intima: “Non può e non deve ripetersi”, quasi “il duce” fosse alle porte. L'occasione è propizia per sfatare un “mito” abusato. Chiariamo subito che la famosissima “marcia” non avvenne il 28 ottobre 1922 e che, se per tale si intende l'assalto armato alla Città Eterna, essa non ebbe mai luogo. Solo il 31 ottobre, invero, circa 25.000 “militi”, stanchi e per niente soddisfatti, sfilarono per il centro di Roma e furono subito spediti a casa. Il governo Mussolini era già insediato e non ne aveva alcun bisogno. I mestatori, però, continuano a rinfocolare una leggenda che fece comodo a fascisti e ad antifascisti: a beneficio dei professionisti della “guerra civile” e a scapito della verità storica.
La disputa sulla “Marcia su Roma” programmata da Forza Nuova per il prossimo 28 ottobre salirà ancora di tono, anche per le improvvide dichiarazioni del sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che intima: “Non può e non deve ripetersi”, quasi “il duce” fosse alle porte. L'occasione è propizia per sfatare un “mito” abusato. Chiariamo subito che la famosissima “marcia” non avvenne il 28 ottobre 1922 e che, se per tale si intende l'assalto armato alla Città Eterna, essa non ebbe mai luogo. Solo il 31 ottobre, invero, circa 25.000 “militi”, stanchi e per niente soddisfatti, sfilarono per il centro di Roma e furono subito spediti a casa. Il governo Mussolini era già insediato e non ne aveva alcun bisogno. I mestatori, però, continuano a rinfocolare una leggenda che fece comodo a fascisti e ad antifascisti: a beneficio dei professionisti della “guerra civile” e a scapito della verità storica. Oggi non molti ricordano Vittorio Valletta. Dal 4 luglio però lo evoca un francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo Economico. Dallo stesso giorno circola il francobollo commemorativo di Giuseppe Di Vittorio (Cerignola, 1892-Lecco,1967), sindacalista generoso, ripetutamente in contrasto con Togliatti, in specie sulla repressione dell'Ungheria da parte dell'Armata Rossa (“una banda di assassini” confidò ad Antonio Giolitti, che uscì dal Partito comunista italiano).
Oggi non molti ricordano Vittorio Valletta. Dal 4 luglio però lo evoca un francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo Economico. Dallo stesso giorno circola il francobollo commemorativo di Giuseppe Di Vittorio (Cerignola, 1892-Lecco,1967), sindacalista generoso, ripetutamente in contrasto con Togliatti, in specie sulla repressione dell'Ungheria da parte dell'Armata Rossa (“una banda di assassini” confidò ad Antonio Giolitti, che uscì dal Partito comunista italiano).  Prima l'uovo o la gallina? Prima l'intesa politica per sollevare l'Italia dal pantano o gli stratagemmi della legge elettorale. Prima il Paese o i “professionisti del potere”? Sicilia a parte (un “caso” che non merita tutta l'enfasi, da politicanti di provincia), la posta in gioco delle elezioni vere, le politiche della primavera 2018, è la conquista del 40-
Prima l'uovo o la gallina? Prima l'intesa politica per sollevare l'Italia dal pantano o gli stratagemmi della legge elettorale. Prima il Paese o i “professionisti del potere”? Sicilia a parte (un “caso” che non merita tutta l'enfasi, da politicanti di provincia), la posta in gioco delle elezioni vere, le politiche della primavera 2018, è la conquista del 40-  Elena fu a lungo tra i nomi femminili più diffusi in Italia: omaggio di ogni ceto alla consorte di Vittorio Emanuele III. Elena Petrovic-Niegos nacque dal principe (poi re) di Montenegro, uno Stato piccolo ma pugnace, bastione della cristianità contro l'islamizzazione della penisola balcanica, giunta sino alle porte di Vienna e respinta col soccorso dei polacchi. Più tardi a ricacciarli fu Eugenio di Savoia, uno dei grandi condottieri della storia.
Elena fu a lungo tra i nomi femminili più diffusi in Italia: omaggio di ogni ceto alla consorte di Vittorio Emanuele III. Elena Petrovic-Niegos nacque dal principe (poi re) di Montenegro, uno Stato piccolo ma pugnace, bastione della cristianità contro l'islamizzazione della penisola balcanica, giunta sino alle porte di Vienna e respinta col soccorso dei polacchi. Più tardi a ricacciarli fu Eugenio di Savoia, uno dei grandi condottieri della storia. Mentre tempestosi venti di guerra sferzano l'Estremo Oriente come altre volte in agosto (1914, 1939...), ricorre il centenario del mese cruciale della Grande Guerra. In poche settimane si consumò l'estremo tentativo di fermare l'Europa sull'orlo della catastrofe. Dopo tre anni di conflitto tutte le potenze erano al collasso. A marzo lo zar Nicola II fu spazzato via. I tedeschi propiziarono l'arrivo di Lenin in Russia: una mina ai danni del governo provvisorio e di Kerenskij, che a fine luglio represse duramente la sollevazione armata a Pietrogrado e ogni opposizione alla prosecuzione della guerra, alimentata da pressioni anglo-francesi e da un cospicuo prestito da parte degli USA, scesi in lotta il 6 aprile ma ancora lontanissimi da incidere direttamente sul suo esito. In aprile-maggio la Francia fu sconvolta da ammutinamenti al fronte e da scioperi a Parigi. La protesta dilagò in Ungheria. Il 19 luglio il Parlamento tedesco propose la “pace sulla base di accordi”. Il 3 agosto si registrarono ammutinamenti anche nella marina germanica.
Mentre tempestosi venti di guerra sferzano l'Estremo Oriente come altre volte in agosto (1914, 1939...), ricorre il centenario del mese cruciale della Grande Guerra. In poche settimane si consumò l'estremo tentativo di fermare l'Europa sull'orlo della catastrofe. Dopo tre anni di conflitto tutte le potenze erano al collasso. A marzo lo zar Nicola II fu spazzato via. I tedeschi propiziarono l'arrivo di Lenin in Russia: una mina ai danni del governo provvisorio e di Kerenskij, che a fine luglio represse duramente la sollevazione armata a Pietrogrado e ogni opposizione alla prosecuzione della guerra, alimentata da pressioni anglo-francesi e da un cospicuo prestito da parte degli USA, scesi in lotta il 6 aprile ma ancora lontanissimi da incidere direttamente sul suo esito. In aprile-maggio la Francia fu sconvolta da ammutinamenti al fronte e da scioperi a Parigi. La protesta dilagò in Ungheria. Il 19 luglio il Parlamento tedesco propose la “pace sulla base di accordi”. Il 3 agosto si registrarono ammutinamenti anche nella marina germanica. L'Italia è un Paese “normale”. La Costituzione fissa gli equilibri tra i Poteri. La disputa aperta a freddo da Giorgio Napolitano contro Silvio Berlusconi sul ruolo svolto dall'Italia nell'aggressione alla Libia di Gheddafi (dal 17 marzo 1911), causa del caos tuttora imperversante a tutto danno del nostro Paese, ripropone un nodo istituzionale, oltre che politico e storico. A chi gli rinfaccia di avere esercitato pressione determinante sul presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per estorcerne l'assenso, l'allora presidente della Repubblica, Napolitano, risponde sdegnato che fu il governo a decidere la partecipazione dell'Italia a una impresa militare senza avallo dell'ONU e a dir poco stupida, perché priva di prospettive politiche locali e globali. Dal canto suo Berlusconi ribatte quanto tutti sanno benissimo: egli e la generalità dei ministri erano contrari all'intervento, nel timore di quanto più volte profetizzato da Gheddafi: il crollo del non encomiabile regime del “Colonnello” avrebbe creato un vuoto incolmabile. Gran Bretagna e Francia andarono oltre e si assunsero la responsabilità dell'assassinio di Gheddafi, ammazzato in una maniera che fa vergogna ai sedicenti esportatori della democrazia. I quali (Obama, Blair, Sarkozy, etc.) dovrebbero spiegare quali siano i frutti liberaldemocratici (o “occidentali”) della “primavera araba”. Del pari, i tanti giornalisti italiani che si spellarono le mani ignorando storia e realtà dell'altra sponda del Mediterraneo dovrebbero ammettere di aver scritto su emozioni anziché per scienza. Si veda, per contrasto, il denso saggio di Tanda Kassis e Alexandre Del Valle, “Comprendere il caos siriano, Dalle rivoluzioni arabe al jihad mondiale” (D'Ettoris Editori).
L'Italia è un Paese “normale”. La Costituzione fissa gli equilibri tra i Poteri. La disputa aperta a freddo da Giorgio Napolitano contro Silvio Berlusconi sul ruolo svolto dall'Italia nell'aggressione alla Libia di Gheddafi (dal 17 marzo 1911), causa del caos tuttora imperversante a tutto danno del nostro Paese, ripropone un nodo istituzionale, oltre che politico e storico. A chi gli rinfaccia di avere esercitato pressione determinante sul presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per estorcerne l'assenso, l'allora presidente della Repubblica, Napolitano, risponde sdegnato che fu il governo a decidere la partecipazione dell'Italia a una impresa militare senza avallo dell'ONU e a dir poco stupida, perché priva di prospettive politiche locali e globali. Dal canto suo Berlusconi ribatte quanto tutti sanno benissimo: egli e la generalità dei ministri erano contrari all'intervento, nel timore di quanto più volte profetizzato da Gheddafi: il crollo del non encomiabile regime del “Colonnello” avrebbe creato un vuoto incolmabile. Gran Bretagna e Francia andarono oltre e si assunsero la responsabilità dell'assassinio di Gheddafi, ammazzato in una maniera che fa vergogna ai sedicenti esportatori della democrazia. I quali (Obama, Blair, Sarkozy, etc.) dovrebbero spiegare quali siano i frutti liberaldemocratici (o “occidentali”) della “primavera araba”. Del pari, i tanti giornalisti italiani che si spellarono le mani ignorando storia e realtà dell'altra sponda del Mediterraneo dovrebbero ammettere di aver scritto su emozioni anziché per scienza. Si veda, per contrasto, il denso saggio di Tanda Kassis e Alexandre Del Valle, “Comprendere il caos siriano, Dalle rivoluzioni arabe al jihad mondiale” (D'Ettoris Editori). Il voto per il ridimensionamento dei vitalizi dei Parlamentari è un misto di demagogia e di antipolitica. È anche una palese violazione di uno dei capisaldi della civiltà giuridica: l’irretroattività delle leggi. Il suo vero bersaglio sono i “politici” quali protagonisti della storia d'Italia. Prendendo a pretesto condizioni oggettivamente assurde (ma create da norme approvate dal Parlamento e dai consigli regionali), quel voto ha lo scopo di “dare una lezione” a chiunque abbia rappresentato i cittadini alle Camere e nelle Regioni. In sintesi è una “legge” profondamente antidemocratica.
Il voto per il ridimensionamento dei vitalizi dei Parlamentari è un misto di demagogia e di antipolitica. È anche una palese violazione di uno dei capisaldi della civiltà giuridica: l’irretroattività delle leggi. Il suo vero bersaglio sono i “politici” quali protagonisti della storia d'Italia. Prendendo a pretesto condizioni oggettivamente assurde (ma create da norme approvate dal Parlamento e dai consigli regionali), quel voto ha lo scopo di “dare una lezione” a chiunque abbia rappresentato i cittadini alle Camere e nelle Regioni. In sintesi è una “legge” profondamente antidemocratica. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha accolto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, a Versailles. L'ha ospitato a pranzo con vista sui Champs Elysées e l'ha condotto dinnanzi al sarcofago di Napoleone a Les Invalides. Gli ha mostrato in sintesi la grandezza della Francia, uno Stato millenario: storia e modernità, identità condivisa nei secoli, malgrado feroci guerre franco-francesi, da quelle di religione alla Fronda, dalla Vandea al “regolamento di conti” tra “liberatori” e “collaborazionisti” all'indomani dell'occupazione germanica, venti volte più sanguinoso di quello italiano dell'aprile-maggio 1945 e nondimeno accuratamente rimosso. Il novantaduenne Pétain, eroe della Grande Guerra, fu condannato alla fucilazione (risparmiata solo per l'età). Però, quand'è il momento, la Francia sta “al di sopra della mischia”. Così vicina all'Italia e così diversa. Anche l'Italia ha monumenti strabilianti. Ovunque. E ne ha di eccelsi in Roma. Ma stenta a farsene vanto e vetrina. Ha una storia unitaria recente. Solo l'anno venturo festeggerà il centenario dell'unione di Trento e Trieste alla Patria: coronamento dell'antico “Patto di Ausonia”.
Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha accolto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, a Versailles. L'ha ospitato a pranzo con vista sui Champs Elysées e l'ha condotto dinnanzi al sarcofago di Napoleone a Les Invalides. Gli ha mostrato in sintesi la grandezza della Francia, uno Stato millenario: storia e modernità, identità condivisa nei secoli, malgrado feroci guerre franco-francesi, da quelle di religione alla Fronda, dalla Vandea al “regolamento di conti” tra “liberatori” e “collaborazionisti” all'indomani dell'occupazione germanica, venti volte più sanguinoso di quello italiano dell'aprile-maggio 1945 e nondimeno accuratamente rimosso. Il novantaduenne Pétain, eroe della Grande Guerra, fu condannato alla fucilazione (risparmiata solo per l'età). Però, quand'è il momento, la Francia sta “al di sopra della mischia”. Così vicina all'Italia e così diversa. Anche l'Italia ha monumenti strabilianti. Ovunque. E ne ha di eccelsi in Roma. Ma stenta a farsene vanto e vetrina. Ha una storia unitaria recente. Solo l'anno venturo festeggerà il centenario dell'unione di Trento e Trieste alla Patria: coronamento dell'antico “Patto di Ausonia”.